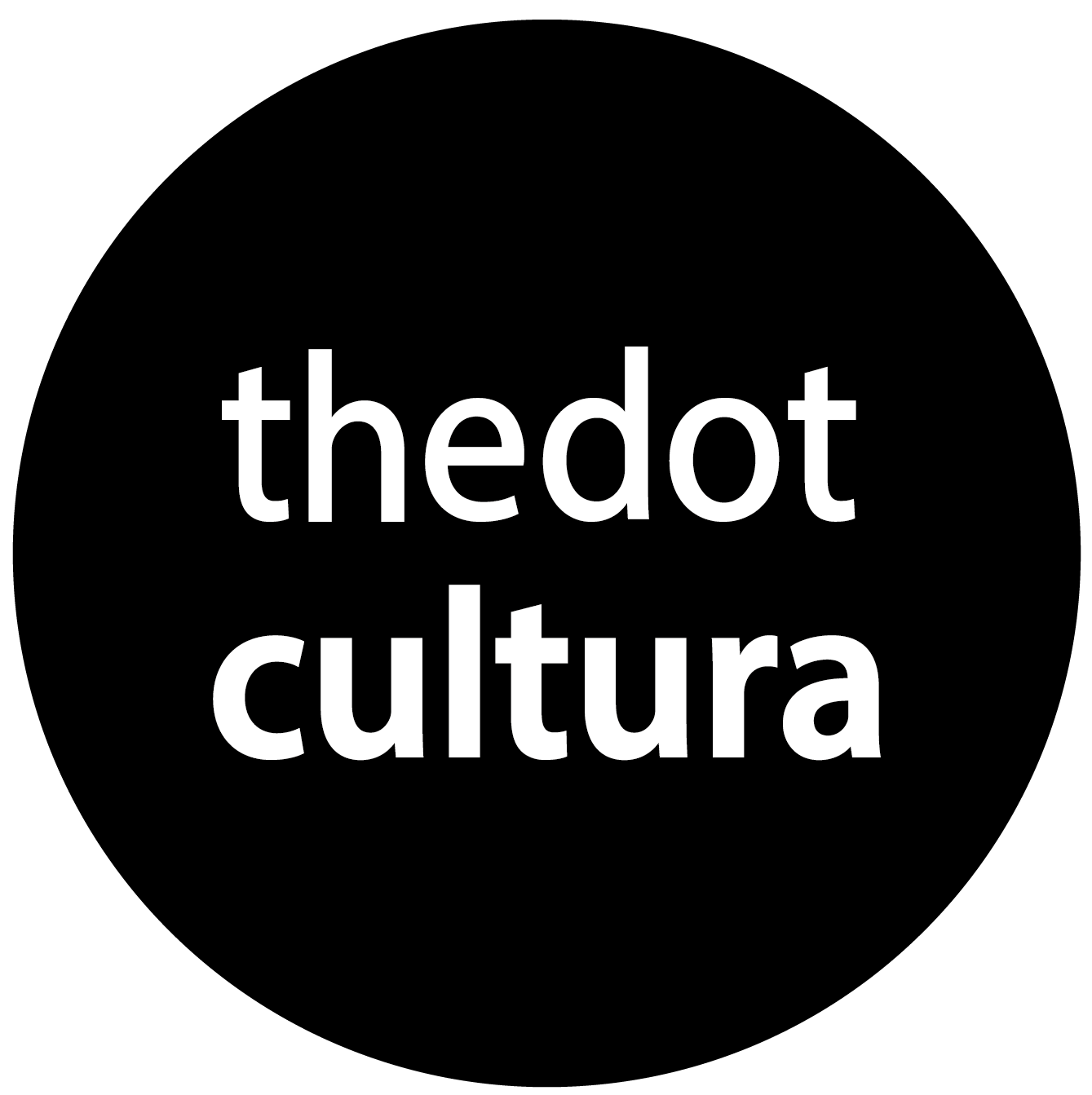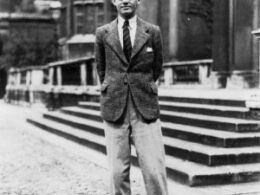Dove sta andando l’Europa? La domanda è quasi banale, dal momento che una guerra in corso nel cuore del Vecchio Continente, con un concreto rischio di escalation, è già di per sé una bella incognita sul futuro da cui è impossibile prescindere. Ma non è solo la guerra a mettere in forse o meglio, a rendere oscuro, il futuro europeo. Infatti, il rischio è che l’esasperarsi di certi bachi, che risiedono nel profondo del sistema che possiamo tranquillamente definire capitalistico, sia già di per sé una buona via per giungere al disfacimento del mondo come lo conosciamo. E non solo per la vecchia Europa, che rischia comunque di soccombere per colpa degli stessi vizi sistemici che qualche tempo fa (non molto tempo fa, a dire il vero) erano rappresentati come punti di forza (profitto quindi Pil, sviluppo all’infinito, produttività unico fine senza contare le macerie umane e ambientali che ciò comportava) , ma dell’intero globo terracqueo che quegli assunti ha assorbito senza riuscire ad opporre niente di realmente alternativo. Situazione plasticamente resa dall’inasprirsi del cambiamento climatico, evidente e invasivo della vita quotidiana di miliardi di persone, con buona pace di chi ancora lo nega.
Analizzando la questione dal punto di vista dei diritti del lavoro, la lontananza delle istituzioni europee è ininfluente sulla vita quotidiana delle persone. Ovvero: sebbene al lavoratore italiano possa apparire lontana e senza ricadute la politica europea, l’impressione è non solo errata, ma in un certo senso ingenua. La contingenza europea, le decisioni europee in materia di lavoro e diritti del lavoro pesano e peseranno sempre più nella dinamica delle regole e dei diritti del lavoro e dunque dei lavoratori. Il punto è molto chiaro nelle parole del sindacalista della Cgil Paolo Cecchi, che introduce un incontro molto interessante su un tema che appare estremamente complesso.
Perché? A spiegarlo, in primis, nel corso del convegno “Prospettiva Europa: quale lavoro, quale cittadinanza, quale futuro per l’Unione”, tenutosi il 30 maggio a Firenze, è una giovane economista, Clara Mattei, docente di economia alla New School for Social Research di New York,
La professoressa Clara Mattei dà fuoco alle polveri. “Non si può parlare di futuro dell’Europa se non si parla della battaglia economica che è di per sé battaglia politica, e deve essere coraggiosa nel puntare il dito sul fatto che il nostro modello economico di capitalismo avanzato non è sostenibile, in quanto si basa per definizione, sulla coercizione economica della maggioranza. L’ordine del capitale è ciò che manda avanti l’eccesso di dividendi degli stakeholders, che continua a moltiplicarsi”. C’è un dato, uscito pochi giorni fa sul Sole24ore, che rende le parole di Mattei pesanti come pietre: “Nel primo trimestre del 2024 sono stati messi a terra 339 miliardi di dividendi. Da ciò si comprende che il nostro sistema economico funziona e cresce , mette i soldi nelle mani dei pochi, mentre finanzia guerre”, con tutto il contorno che ciò comporta. Un sistema insomma cui “fa bene” il finanziamento della guerra. Perché?
“Siamo in un sistema che funziona secondo la logica dei profitti, che è completamente distaccata, anzi ,reprime la logica dei bisogni – spiega Mattei – per questo dobbiamo essere coraggiosi e ripensare un’Europa che riesca a mettere in discussione davvero i cardini stessi del capitalismo. E’ un progetto molto ambizioso perché l’Europa stessa ha come Costituzione dell’austerità”,
Ma cos’è l’austerità? “Nel mio saggio “L’economia è politica” – continua Mattei – l’austerità è qualcosa di non marginale nel nostro sistema economico,, ma è funzionale e nel DNA del capitalismo, in quanto serve a mantenere la maggioranza della popolazione in una situazione di vulnerabilità che in qualche modo chiude lo spazio all’immaginazione politica per un futuro diverso”. In concreto, l’austerità si vede nei tagli alla spesa sociale. Ciò non significa che lo Stato “non spende soldi”, che è il ritornello con sui si giustificano di solito le politiche dei tagli al sociale, sotto il pretesto che “non ci sono soldi” o si “deve risparmiare”, in quanto, spiega Mattei, “lo Stato spende; non solo per ripagare il debito pubblico, ovvero gli interessi sul debito, quindi soldi che finiscono direttamente nelle tasche di coloro che prestano i grossi capitali, ma anche nel settore industriale militare, o per rendere in qualche modo privi di rischi tutti gli asset management nell’economia green”.
Ovvero, dice Mattei, “queste sono risorse pubbliche dello Stato che non vanno ai cittadini (sotto forma di servizi sociali, ad esempio, ndr)”, ma finiscono per obbedire alla finalità di “costante estrazione del plusvalore, che finisce nelle mani di coloro che gioiosamente si dividono i dividendi esagerati e i tassi di profitti esagerati che stanno continuando a crescere all’interno delle nostre società”.
Ma il concetto “austerità” contiene anche un altro elemento, ovvero la cosiddetta tassazione regressiva. ” Esemplificando, che chi ha di più paga di meno. Più scientificamente, “coloro che vivono di ricchezza accumulata pagano meno tasse rispetto ai lavoratori “. Paese emblematico in cui ciò avviene , sono naturalmente gli Usa. Ma anche in Europa, dice Mattei, la direzione è quella dell’austerità monetaria.
E a questo punto, ecco un altro problema irrisolto: ovvero che l’Europa non controlla la propria politica monetaria, come avviene invece in America. “La Banca Centrale è la più indipendente di tutte le banche centrali – dice Mattei – potrebbe anche sembrare un dato positivo, ma “indipendenza” in questo caso significa indipendenza dalle intrusioni della politica”, Ovvero dai controlli, aggiungiamo noi, o come meglio dice Mattei, “dall’intrusione della partecipazione collettiva alle decisioni della politica monetaria europea”.
Tirando le fila, dice ancora Mattei, “questa Europa si basa non solo sull’austerità ma anche sulla tecnocrazia” che si presenta come apolitica, ma è frutto di un processo politico.
Soluzioni e proposte? Al netto del fatto che ci vuole il coraggio di procedere al riconoscimento franco dell’insostenibilità di questo sistema, secondo Mattei si dovrebbe procedere nel senso di un riconoscimento delle realtà, che esistono anche in Italia, in cui si verifica la partecipazione democratica all’economia (l’esempio citato è quello dell’ex Gkn e dei progetti operai di rientrare nel circuito produttivo con produzioni sostenibili e green).
La situazione dell’Europa riguardo al futuro non può prescindere da un altro grande tema, oggetto di un focus del professor Francesco Saraceno, ovvero l’episodio inflazionistico di cui stiamo vivendo (si spera) gi ultimi strascichi. Da dove viene? Si potrebbe riprodurre?
Tornando indietro nel tempo, fino al 2020, ricorda Saraceno, ovvero fino alla pandemia e alla ripartenza successiva alla pandemia, “ci trovavamo in una situazione diametralmente opposta rispetto a quella degli ultimi due anni”. Ovvero, “ci trovavamo con un tasso di inflazione estremamente basso, che ballava fra lo 0 e l’1% e che le banche centrali cercavano disperatamente di riportare al 2%”. All’epoca, si parlava di stagnazione secolare. Le analisi dell’epoca tendevano a individuare tutta una serie di motivi per cui la domanda rimaneva troppo bassa e l’inflazione non riusciva a portarsi al livello convenzionalmente considerato normale, del 2%. Nel 2020, quando inizia la pandemia, siamo in questa situazione. “Arriva la fase post covid dei 2021 e insieme arriva anche una fiammata dei prezzi, destinata a durare fino all’autunno 2022”.
Un’inflazione che ha una natura, secondo Saraceno, molto precisa e identificabile, ovvero è un’inflazione di natura “strutturale”. Cosa significa? “Da un lato, ci troviamo di fronte a una specie di riallocazione settoriale della domanda”, ovvero la domanda si comporta in modo diverso rispetto ai settori; ci si trova di fronte a delle nuovo abitudini di consumo rispetto al pre covid, cambiamenti che ancor ora, “nel 2024, non sappiamo quanto saranno duraturi o effimeri”. Una riallocazione settoriale che, dice Saraceno, rende “frastagliata anche l’inflazione”. Non solo. Fra le cause, il professor Saraceno indica anche la “disarticolazione delle catene del valore”, vale a dire l’effetto covid sulla produzione, che ha colpito in modo diverso e tempi diversi pezzi interi, ad esempio dell’economia cinese. Anche l’instabilità geopolitica ha ovviamente avuto un impatto, “con interi Paesi che rilocalizzavano le proprie produzioni in Paesi meno rischiosi dal punto di vista geopolitico”. Senza contare l’impatto della guerra sui prezzi dell’energia, che “peraltro – ricorda Saraceno – guardando alla disarticolazione che stava avvenendo, aveva visto i prezzi in amento ben prima del 2020”.
Di fronte questo quadro, ricorda Saraceno, le banche centrali in prima battuta non si mossero, ritenendo appunto l’inflazione di natura strutturale e quindi che non fosse “roba loro”, in quanto non si affronta l’inflazione strutturale con la politica monetaria.. Ma il suo perdurare e la guerra, indussero le Banche centrali a intervenire, utilizzando lo strumento tradizionale della politica monetaria per contenerla: “si è recuperato il vecchio vate del ,monetarismo, Milton Friedman, ovvero, qualunque sia la natura dell’inflazione, questo non cambia la risposta, che è di politica monetaria. La ricetta: restrizione monetaria , raffreddamento dell’economia, portare giù i prezzi. Si diffonde anche il ragionamento, che se non si combatte l’inflazione, si penalizzano i più poveri”. Risultato: innalzamento dei tassi di interesse. “Entra prepotentemente nel discorso l’impatto redistributivo dell’inflazione.
Effettivamente, l’inflazione è “una tassa sui poveri. Perché succede? Ci sono molti canali attraverso cui ciò succede, ad esempio la diversa composizione dei panieri dei beni di consumo”. Non solo. E’ ormai dato del tutto certo che per esempio le fasce più povere, quando li hanno , hanno più difficoltà a tutelare i loro risparmi in caso di inflazione, anche perché la loro spesa è quasi totalmente assorbita da beni primari (abitare, spesa alimentare). La questione è semplice: quando le cose vanno male, vanno male per i più indifesi. Quando vanno bene, vanno bene in buona sostanza per i ricchi.
Al di là della questione morale che ognuno si vede con se stesso, un sistema con grandi disuguaglianze è insostenibile. “Una società con eccessiva disuguaglianza è una società che fa fatica a produrre ricchezza – spiega l’economista – che distoglie risorse dal settore reale verso quello finanziario, che non investe abbastanza sul capitale umano”. Un altro addentellato, è che “la maggioranza che perde sempre comunque vadano le cose, sviluppa un problema di adesione verso il contratto sociale”. Vale a dore che oggi c’è una massa crescente di popolazione che rifiuta di seguire le regole, ovvero, ad esempio, non si reca a votare. Rifiuta di partecipare al processo democratico, quindi orienta la propria scelta o no nel non voto, o quando vota, sceglie partiti antisistema .
Insomma, ci vorrebbe una redistribuzione della ricchezza. Una certa speranza Saraceno la apre con l’avvento della rivoluzione tecnologica di cui stiamo cominciando a vedere gli albori. legata alla transizione ecologica. “come i frutti andranno redistribuiti e i costi pure, bisognerà aspettare i risultati per valutarli”.
Tornando all’inflazione, come ci si doveva comportare? Se l’inflazione, come ha spiegato Saraceno, è frastagliata per settori, l”utilizzo di uno strumento unico da parte della Banca Centrale, non è corretto. “Se l’inflazione è un fenomeno multiforme e ha delle cause multiple – dice Saraceno – la risposta deve essere altrettanto multiforme e utilizzare strumenti multipli”. Per questo lo strumento della Banca Centrale, che è un solo strumento, “un tasso di interesse che colpisce tutti i settori allo stesso modo, se sale li raffredda tutti, se cala li stimola tutti, ma non è in grado di differenziare per settore e tipo di problema, di fatto è una specie di clava”. spiega Saraceno: “Dobbiamo usare una serie di strumenti che siano altrettanto variegati come sono variegate le cause dell’inflazione”. utilizzando non la clava del tasso d’interesse ma il fioretto delle politiche industriali, “riducendo le tensioni inflazionistiche a livello microeconomico lì dove esse accadono “. Quindi, investimenti pubblici e privati , incentivi, regolamentazioni.
Altro punto, il ritorno auna politica dei redditi. Significa “tornare a una gestione del processo economico nelle fasi di crescita come nelle fasi di rallentamento, in cui la distribuzione del reddito sia fra gli obiettivi di chi costruisce le politiche economiche”.
Tirando le fila, dice Saraceno, tutto ciò non è stato fatto. “La lotta all’inflazione è stata delegata alle banche centrali, che come spiegato , non era strumento adatto né alla natura dei problemi, né tantomeno alla soluzione degli stessi”.
In realtà, sia Usa che Eu non sono stati con le mani in mano, ma i risultati non sono stati evidenti. Ma un altro punto si pone, come spiega Saraceno: la politica monetaria, nel dispiegare i suoi effetti sull’economia, non è rapida, Anzi., Ci vuole tempo, Ciò significa che gli effetti delle decisioni di politica monetaria delle banche centrali, cominciano a dispiegare i propri effetti ora, quando l’inflazione è quasi tornata nei valori normali.
il risultato prevedibile , dice Saraceno, è “che i tassi cominceranno a mordere quando l’inflazione non ci sarà più, causando un rallentamento dell’economia”. Ma in questo moento accade, anche, dice Saraceno, che i salari stanno recuperando terreno, ovvero, “man mano che i contratti giungono a termine, si rinnovano con il recupero dei salari”. Dunque, si potrebbe parlare di un riequilibrio in un certo senso naturale o strutturale del sistema.