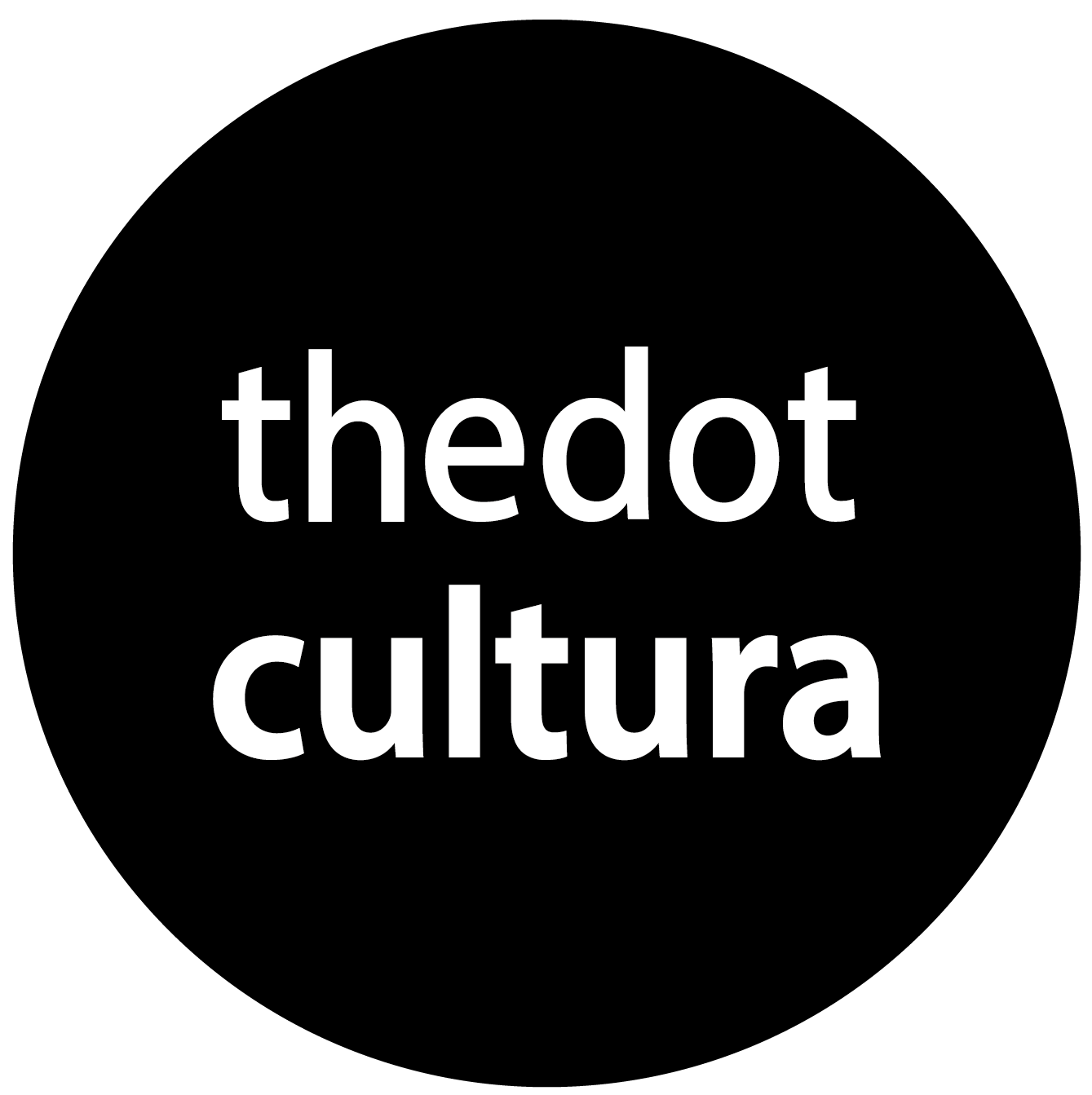Firenze – Storia di strade, ponti, fiumi: storia di Pontassieve è un saggio prezioso di Vincenzo Benvenuti per conoscere la storia di Pontassieve e della Valdisieve. Un libro ricco di informazioni, ma anche di belle foto e di dettagliate piantine. Leggendolo si vede anche come esso contribuisca in modo significativo alla storia generale della Toscana e dell’Italia in quanto si tratta di un territorio crocevia di popoli sia sul piano militare che economico, Come possiamo riscontrare in questa conversazione con l’autore
Nel titolo del tuo saggio è già racchiusa la “ cifra” dell’importanza storica di Pontassieve….
“E’ l’orografia del territorio che ha determinato l’importanza di Pontassieve. Volendo recarsi da Roma al nord (e viceversa), nell’antichità non potevano passare dalla Maremma a causa della malaria e attraversare l’Appennino centrale era difficile. L’unica strada praticabile era lungo il corso dell’Arno, ma la Sieve, incrociando l’Arno era un ostacolo difficile, inoltre lo snodo di Pontassieve permetteva di raggiungere facilmente l’Adriatico. Quindi, prima gli Etruschi (ponte di Vico), poi i Romani (ponte Maggio) si ingegnarono costruendo ponti sulla Sieve. In pratica Pontassieve era l’ombelico d’Italia; sino alla costruzione dell’autostrada del Sole e della direttissima ferroviaria tutto il traffico Nord-Sud-Est passava per Pontassieve. Di questo si resero conto pure gli Alleati durante la seconda guerra mondiale : Pontassieve è stato uno dei posti più bombardato.
A causa del grande traffico a Pontassieve c’era uno dei più grandi (e ottimo ) ristoranti d’Italia: il “Girarrosto” così detto dal girarrosto gigantesco (in acciaio inox) costruito dall’officina Piselli”.
Qual è l’importanza degli insediamenti etruschi nell’area di Pontassieve ?
“Gli Etruschi hanno sempre edificato e costruito strade in zone collinari, i romani non avevano particolari preferenze, l’importante era che l’esercito potesse muoversi il più velocemente possibile. Nel mio saggio ho riportato solo i più importanti ritrovamenti; la lista e descrizione completa si trova nel capitolo “La presenza umana dall’antichità al medioevo” di V. Ferrini in “Le Antiche Leghe””.
Venne poi l’’epoca dei Castelli…a cominciare da Castel Sant’Angiolo. Nel tuo saggio riporti un passo di Matteo Villani “E in questo medesimo tempo (1363) ne fece porre il comune una (fortificazione) di nuovo al Pontassieve, ove si dice di Filicaia, la quale è più per ridotto di una guerra, che per abitazione o per mercato che vi si potesse allignare( M.Villani “Cronica” libro settimo cap. XLV)”. Ma scrivi anche che l’origine è di questo nucleo fortificato è assai più antica.
“L’incastellamento si fa risalire alla morte di Carlo Magno; con la dissoluzione del suo impero i vari referenti che aveva creato (lo stesso era stato fatto dai re barbarici) si ritrovarono ad essere proprietari di vaste (o piccole) zone di territorio e quindi cominciarono a costruire dei castelli (intorno all’anno 1000) per la loro difesa. Spiegato molto bene in “Storia d’Italia” di Montanelli/Gervaso. Il territorio di Pontassieve è considerato quello, in provincia di Firenze, con il maggior numero di castelli, fatto dovuto, molto probabilmente, alle caratteristiche del territorio. La descrizione completa di tutti i castelli è riportata in un preciso capitolo:“ I castelli della podesteria del Ponte a Sieve” a cura di A. Boglione e I. Moretti in “Le antiche Leghe”; nell’elenco non è riportato Castel S. Angiolo in quanto non si tratta di un vero castello, ma di una “terra murata”. In pratica i fiorentini, per difendere il nodo di Ponte a Sevis circondarono di mura una collina; nei capitoli 6.3 e 6.4 del mio libro è riportata la storia del castello”.
L’importanza della presenza di famiglie feudali come il Quona e i Guidi.
“Da quanto riportato in precedenza, alcune famiglie diventarono proprietarie del territorio. Da noi le principali furono i Filicaia e i Quona; pure i conti Guidi (signori del Casentino) influenzarono la nostra storia.
FILICAIA: I “signori” da Filicaia, ( il cui cognome forse viene dal latino Caius fili trasformato in figlio di Caio) occupavano gran parte del territorio pianeggiante lungo i fiumi; non possedevano un castello, ma avevano delle case torri. Erano una famiglia rispettata da tutti (non si hanno notizie di lotte con Firenze o con i conti Guidi), molto probabilmente perché non si sono mai schierati con Firenze o con i conti Guidi, oggi si direbbe che tenevano “un basso profilo”. Le loro case torri sono ancora in piedi e costituiscono il primo embrione del paese di Pontassieve: purtroppo la nostra amministrazione comunale non le ha acquistate (già successo con la portaccia) e le ha circondate con un posteggio ed una strada; avrebbero dovuto dare alle case la dovuta importanza. Nel 1217 Giovanni da Filicaia partì per la quinta Crociata. Ritornò nel 1227 dopo essersi coperto di gloria in Egitto.Nella locandina dei ”Festeggiamenti popolari” in occasione dei 50 anni (1905) del miracolo di Pontassieve si riporta il corteggio storico che rievocava il ritorno di Giovanni da Filicaia dalle crociate:“ Filippo da Quona, cavaliere di Carlo Magno imperatore, capo dei Ghibellini e Ruggero da Quona, priore della Repubblica fiorentina con i loro seguiti rendono speciali onoranze a Giovanni Da Filicaia….” La famiglia Filicaia è tuttora esistente.
QUONA: I Quona possedevano un castello nella zona oggi detta “Trentanove”, la storia della famiglia è descritta nei capitoli 6.2.1 e 6.3 del mio libro.
GUIDI: I conti Guidi erano i più potenti signori della zona: il loro castello si trovava a Poppi nel Casentino, ma controllavano pure il nostro territorio con un visconte che risiedeva nel castello di Monte di Croce (sopra il Fornello), avevano per alleati i Quona e controllavano il monastero di Rosano. La storia è riportata nel capitolo 6.7 del mio libro”.
Nel tuo libro si parla anche di luoghi come il Portuccio, i Reduci, i Cavallacci ,,,quale il loro significato e il loro valore ?
“Portuccio: Nel 1547 una alluvione si portò via il ponte sulla Sieve (pag. 34 del mio libro). Per quanto scritto al punto 7, si dovette procedere a mettere delle barche tra le due rive. Dal lato Pontassieve le barche partivano dal Portuccio (detto pure porto di Calderino o Carderino) in fondo all’omonimo vicolo in Borgo e arrivavano sull’altra riva dove ancora esiste lo scivolo per tirarle in secca. ( di fronte al forno di S. Francesco)
Reduci: così veniva chiamata la palazzina all’interno delle case minime, costruita per i reduci della seconda guerra mondiale; si può vedere solo andandoci. Quasi nessuno in paese la conosce.
Cavallacci: così veniva chiamata ( sino a metà ‘900, in seguito chiamata draga dall’installazione di una draga per recuperare la rena dai fiumi) la confluenza tra Arno e Sieve; il nome deriva dal fatto che quando un cavallo moriva per circostanze non chiare veniva buttato nel fiume”.
E di leggende come la locanda del Malcantone…
“Quanto successo alla locanda del Malcantone nel 1730, non è leggenda: il ragno è esposto nella bacheca dei ragni velenosi al museo della Specola. Non assomiglia a nessuno dei 5 tipi di ragni velenosi che si trovano in Italia; il veleno della malmignatta, detta pure “vedova nera mediterranea o ragno di Volterra” può essere mortale”.