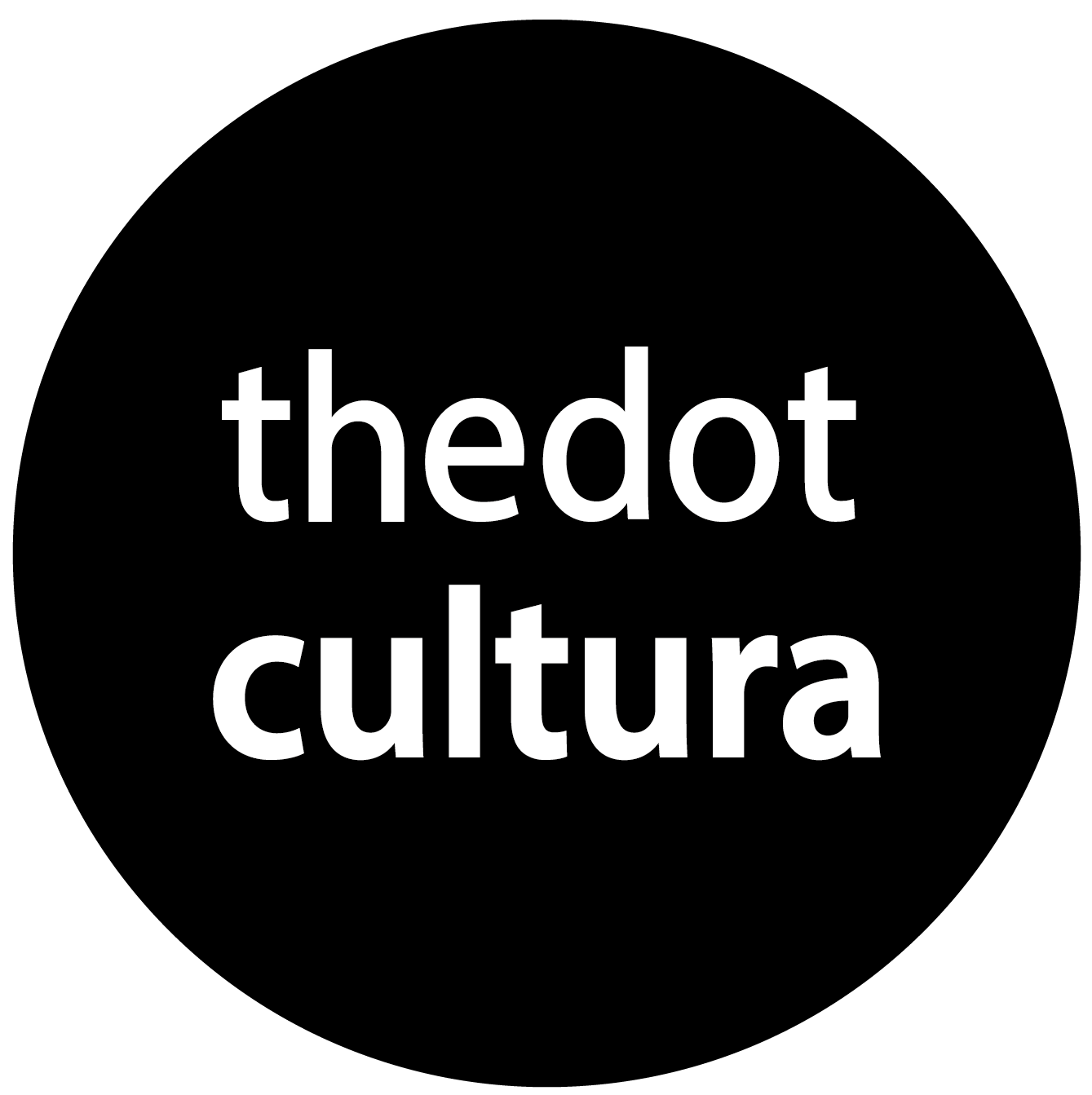Un primo incontro, che vuole essere l’avvio di una serie per fornire strumenti e spunti di riflessione in un momento storico particolarmente complesso e per certi versi inedito come quello attuale, si è tenuto venerdì 12 aprile nella sede della Fondazione Spadolini. La tavola rotonda ha posto l’attenzione sui giovani, politica, cultura e prospettive di rilancio per il futuro. Non ultima l’Europa. Ospiti e relatori, i giornalisti Stefano Folli e Vincenzo Romeo, il presidente della Fondazione Fratelli Rosselli già deputato, sottosegretario e ministro della Repubblica Valdo Spini, il presidente di Etica Sgr Ugo Biggeri, l’esperto di microfinanza Roberto Trinca, il professore emerito dell’università di Princeton Maurizio Viroli.Gli anni che verranno, i giovani e i nuovi scenari di politica interna ed internazionale” i titlo dell’incontro. Il professor Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini, docente di storia del giornalismo alla facoltà Cesare Alfieri di Firenze, editorialista del Quotidiano Nazionale ha presenziato l‘incontro, con il dottor Paolo Gacci, presidente della Fondazione I Medici F3, che, con Simone Aiazzi, avvocato ed esponente della segreteria nazionale del Movimento Repubblicani Europei, hanno organizzato l’evento.
Introducendo i vari relatori, il padrone di casa, il presidente della Fondazione Spadolini Ceccuti, lancia l’interrogazione forse più inquietante: è un’utopia che giovani e politica tornino a incontrarsi? Ricordando il grande impegno di Spadolini docente e politico nei confronti del mondo giovanile, il professor Ceccuti sottolinea che il filo che unisce politica e giovani si può riallacciare se “i giovani ritrovano nella politica quella casa di vetro per cui Spadolini si era battuto prima ancora che cominciasse la crisi dei partiti”.
Il presidente della Fondazione I Medici F3, Paolo Gacci, rilancia il tema ricordando che la vera questione risiede nel ridare motivazione ai ragazzi per riavvicinarsi alla politica. Il punto che ingenera sfiducia, “la lentezza delle risposte della politica” in un mondo veloce, che corre sul filo di internet e che ingenera insoddisfazione e “anche un po’ di disprezzo”. Inadeguatezza che dà la sensazione che la politica non assolva più alla sua funzione precipua, difendere valori e dare risposte. Gacci conclude: “i valori, solidarietà, giustizia, libertà, non sono misurabili, ma fanno parte dell’ossatura del nostro Paese. L’invito è alla politica a fare a sua parte, ma a noi e in particolare ai giovani, è quello di provare a cambiare le cose”.
Simone Aiazzi, “mazziniano da sempre”, presenta più diffusamente il progetto che ha prodotto l’incontro. “La giornata odierna non è che il primo passo di un progetto permanente che nei suoi intenti vuole avvicinare o riavvicinare i giovani alla politica come impegno civile nella società. Il tentativo è di aprire un dialogo, offrendo alle generazioni più giovani gli strumenti per trovare risposte ad un mondo che si è caratterizzato negli ultimi anni per una pandemia che ha prodotto profonde crisi economiche e sociali, una guerra alle porte con l’Europa, un progresso tecnologico che avanza così rapidamente che se da un lato offre enormi opportunità, dall’altro lascia indietro grandi strati della popolazione, generando incertezze, paure e anche diseguaglianze. Tutti elementi che hanno generato un diffuso senso, anche e soprattutto fra i giovani, di inadeguatezza e incertezza che appare quasi insormontabile. Spesso i giovani reagiscono con rassegnazione con rabbia, che sono i sentimenti peggiori”. Come controbilanciare questo, ascoltare e comprendere i disagi delle nuove generazioni.
“Nella politica odierna – continua Aiazzi – non emerge una sentita esigenza di ascoltare e comprendere i disagi dei giovani, spesso destinatari di messaggi propagandistici e ideologici che generano ulteriori conflitti e smarrimenti. E’ in questo passaggio che si vuole inserire il progetto. “Mettere i giovani a conoscenza di ciò che gli sta intorno – continua Aiazzi – come ad esempio la costruzione di un’Europa unita, strumento di aggregazione federata capace di riaffermare il concetto di unità nella diversità, il principi di libertà, solidarietà, per affrontare le sfide più ardue che ci vengono incontro. Stati e Paesi non riescono più da soli a far fronte ai problemi globali. Da qui si dovrà ripartire, anche magari richiamandoci al concetto di Patria, che in tanti modi viene declinato in questi tempi; un luogo in cui le aspirazioni di tutti si fanno bene comune”.
“Quando ci si pone il problema dei giovani e la politica – dice Stefano Folli – non dobbiamo porlo nei termini “giovani e partiti”, dal momento che ormai i partiti non esistono più. Il rapporto dei giovani con la politica va quindi inteso come rapporto con le istituzioni, la scuola, il vivere civile nella sua più ampia accezione. Da alcuni sondaggi emerge che buona parte dei giovani sia convinto che la strada per riprendere contatto con la politica, infischiandosene dei partiti, sia la democrazia diretta. Ma la democrazia diretta è evidentemente una mistificazione, una modalità inapplicabile in una società moderna. Ciò che è applicabile è una democrazia che non si limita a uno scenario in cui la partecipazione è data dal rito elettorale, ogni tot di tempo”. Tutto ciò che esiste come incontro, mondo no profit, associazionismo, diventa modalità di partecipazione, secondo Folli, alla vita della comunità. “Forse oggi è addirittura la modalità privilegiata, perché i modi classici si sono attenuati”, prosciugati della loro capacità di coinvolgimento. Come ricreare la coscienza politica? “Una delle risposte credo possa essere la presenza di uno Stato che non ha consapevolezza di sé, della sua importanza e di dove vuole andare”. Folli sottolinea anche la scarsa passione che suscita l’ideale europeo, la necessità di ricostruire non solo l’Europa, ma anche lo Stato, le istituzioni, un concetto di scuola meno stupido di quanto sia ora praticato.
“Siamo in una sorta di tenaglia – dice l’on. Spini – chi vota ha dimostrato una grande capacità di cambiamento, con percentuali del 30% per personaggi che poi sono caduti fragorosamente; dall’altro lato, cresce la percentuale di chi non vota. Quindi la tenaglia è questa: chi vota lo fa per infatuazione momentanea, per rancore verso la classe dirigente in campo e dall’altro lato chi ritiene che la classe dirigente sia sì al volante di una macchina, ma che questo volante non riesca a trasmettere gli impulsi al motore. Il problema in Italia è tanto più complicato perché abbiamo assistito, per diversi motivi, alla distruzione delle nostre radici. La situazione particolare dell’Italia rispetto agli altri paesi europei è dovuta al fatto che c’è stata un’interruzione dei valori e delle radici”.
Come rimediare? Tornando al tema, giovani-Europa-politica, l’accento viene posto dall’on. Spini sulla scarsa consapevolezza circa la cultura come strumento di unione. “E’ un guaio, perché invece istituzioni diversamente finanziate, come l’Erasmus, hanno dimostrato veramente un grande entusiasmo a livello europeo. Direi che in questa Europa, che ha abbandonato il progetto spinelliano e ha pensato che si potesse procedere per gradi funzionali, forse questa Europa ha curato poco la formazione di una cultura europea, pur essendoci tutti i presupposti per poterla fare”. Da qui, quale può essere il rimedio per la tenaglia citata? “Credo che la ricostruzione di un tessuto politico passi per due o tre stadi: il primo è senza dubbio quello delle associazioni. Se i partiti sono morti, al contrario fondazioni, istituzioni e associazioni sono molto vivaci. I partiti hanno un potere: quello di fare le liste e quindi, se lo ritengono, di fregarsene di ciò che avviene attorno a loro. Tuttavia, chi ha l’intuizione di rimettere insieme la società civile che fa cultura e quella che fa politica, credo possa avere un giacimento interessante. L’altro è che l’aspetto comunitario della politica, non più assicurato dai partiti, si possa trovare nelle associazioni, che possano a loro volta ricadere sui partiti. Cosa influisce la politica? La comunità oggi poco, la televisione e i social. La grande scommessa è far giocare i social insieme, social che hanno doppia valenza, negativa ma anche di apertura alla partecipazione democratica. Se ho un bel seguito di seguaci sulle piattaforme social posso anche fare a meno delle tv. Tirando le fila, bisognerebbe riuscire a creare una condizione di comunicazione fra questi tre aspetti, vita comunitaria, ruolo delle tv e dei social”.
Il terreno di prova? “Naturalmente, le lezioni europee dell’anno prossimo – dice Spini – che hanno una posta in gioco molto evidente: nel 2019 si forma la cosiddetta maggioranza Ursula. Le forze populiste e sovraniste vengono fronteggiate e si forma una maggioranza che ha come asse Popolari-Socialisti. Nel novembre, viene sconfitto Trump ed eletto Biden. Nel 2024 ci saranno queste due scadenze decisive, elezioni in Usa e elezioni europee. Per quanto ci riguarda l’esito europeo sarà decisivo: è strano che tutte queste forze cui ci riferiamo, europeiste, federaliste, ecc. non abbiano ancora posto il problema delle elezioni europee, mentre l’ha posto la presidente del consiglio Giorgia Meloni che ha detto in modo esplicito che l’obiettivo per le prossime elezioni è rompere l’asse Popolari-Socialisti per sostituirlo con l’asse Popolari-Conservatori”. Ed è su questo, dice Spini, che le forze europeiste si devono mobilitare anche ne coinvolgimento delle fasce giovanili.
Di giovani e secolarizzazione si occupa invece il caporedattore del Tg 2, il vaticanista Vincenzo Romeo, che mette in luce il pericolo del venir meno della dimensione spirituale nella psicologia collettiva giovanile. Mentre Roberto Trinca, esperto di microfinanza, mette in luce la fragilità dei giovani per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro, uno dei grandi temi odierni, suggerendo un maggior investimento nel capitale umano, il professore emerito Maurizio Viroli sottolinea la differenza assoluta, foriera di confusione anche e in particolar modo fra i giovani che si avvicinano a partiti di destra e dichiaratamente fascisti, fra nazionalismo e patriottismo.
“Il fascismo fu nazionalista, non patriota. Fra patriottismo e nazionalismo c’è un radicale contrasto ideale e politico. Se avessi la possibilità di interloquire con questi giovani, li inviterei a leggere non le pagine degli antifascisti, ma degli ideologi del fascismo. Per esempio, se leggessero quello che Giovanni Gentile scriveva nel 1936, leggerebbero che Gentile sosteneva che il patriottismo risorgimentale e segnatamente il patriottismo mazziniano aveva “il grave limite di coltivare l’assurda idea che il fine della Patria è l’umanità”. Non solo questo. Secondo Gentile, il patriottismo mazziniano era del tutto in contrasto con la concezione fascista della vita come lotta “santificata dal martirio per affermare la forza e la vitalità delle nazioni”. Quindi, sono gli ideologi del fascismo che sostengono che il fascismo non c’entra niente con il patriottismo del nostro Risorgimento, segnatamente il patriottismo mazziniano”.
Un concetto di Patria e patriottismo che Calamandrei spiega in una lettera, come dice il professor Viroli: “Una delle colpe più gravi del fascismo è stata proprio questa, uccidere il senso di Patria, perché il nome di Patria è stato per vent’anni affiancato all’idea della boria nazionale (…), dall’autoritarismo intimidatorio da teatro di marionette, dal tono della radio nazionale (…)”.
Riferendosi infine all’Europa, spiega Viroli, “Alla Patria europea si arriva ove si riconosca che il patriottismo del Risorgimento e il patriottismo antifascista hanno sostenuto l’ideale europeo, con grande forza ideale e grande coerenza politica. Nel 1932, Croce così si esprime: “Per intanto, in ogni parte d’Europa si assiste al germinare di una nuova coscienza, di una nuova nazionalità e a quel modo che, or sono settant’anni, un napoletano dell’antico Regno o un piemontese del Regno Subalpino si fecero italiani, non rinnegando l’essere loro anteriore, ma innalzandolo e risolvendolo in quel nuovo essere, così i francesi, i tedeschi, gli italiani s’innalzeranno a europei, i loro pensieri indirizzeranno all’Europa (….)”. Dunque, conclude Viroli, “si può sviluppare una coscienza europea se prima e contemporaneamente, è stata sviluppato il giusto tipo di patriottismo, ovvero l’amore per gli ideali della libertà e della tolleranza. Non si può arrivare all’Europa ignorando le Patrie, o addirittura parlandone con sufficienza e distacco”.
Lo sgomento di un cambiamento irreversibile in atto (quello climatico) mai dato prima per l’umanità, e il non ascolto da parte delle istituzioni a questo smarrimento dei giovani, è il tema con cui si apre l’intervento di Ugo Biggeri, presidente di Etica SGR . “Abbiamo un tema epocale che antropologicamente non comprendiamo, non abbiamo un linguaggio capace di intercettare quello dei giovani, non ci applichiamo”, dice Biggeri.
“La finanza ha tre fallimenti enormi, e sono al tempo stesso tre sue doti meravigliose. E’ potentissima nel gestire i rischi, che individua, gestisce, mitiga e commercia; dovrebbe essere molto brava a allocare le risorse, il terzo è ‘idea del libero mercato. Tutte tre questi passaggi con in crisi pesantissima. Gestione dei rischi, dagli anni ’60 si sa che, se non veniva aiutato lo sviluppo dei paesi rimasti indietro, saremmo giunti all’ondata di migrazione epocale che stiamo vivendo. I cambiamenti climatici, noti da tempo, non sono stati gestiti E’ difficile convincere i giovani che questo sistema funziona”.
Per quanto riguarda l’efficiente allocazione delle risorse, “oggi -dice Biggeri – di soldi ce ne sono tantissimi, che vanno in mercati puramente speculativi, nei mercati dei derivati. Alle imprese, a chi fa le cose, non arriva nulla. L’allocazione delle risorse è fallita. E’un rischio che già nel 1979 era stato sottolineato da James Tobin, che proponeva quella ormai nota come la Tobin Tax. Ovvero la tassa sulle transazioni finanziarie. La libertà di mercato? Esisterà ovunque, ma in finanza no. Ci sono otto banche che controllano il 60% del mercato dei derivati e quasi naturalmente si mettono d’accordo”. Ma la politica? “Ad ora non pervenuta. I pontefici invece, Benedetto XXVI e Francesco I, con due encicliche hanno voluto mettere sotto attenzione il tema. Il primo, mettendo in luce la responsabilità morale di approfittare dello sfruttamento lavorativo mondiale, il secondo mettendo il punto sull’efficienza intesa come considerazione e misurazione degli impatti sociali e ambientali. Accanto alla variabile profitto, devono esserci le variabili ambiente e sociale. Poi, consideriamo gli obiettivi delle Nazioni unite, che sono 17 ma con 167 target. Il profilo interessante è che un sacco di obiettivi riguardano noi, non sono più per i Paesi in via di sviluppo. Il che è come dire: “Signori, il sistema economico non sta funzionando”. Si sta parlando di obiettivi per la sopravvivenza, e si torna a quanto dicono i giovani”.
“Se prendiamo sul serio il problema, gli strumenti per risolverlo ci sono. L’Europa obbliga tutti i fondi di investimento e tra poco anche le banche, che dovranno comunicare la sostenibilità delle operazioni. La storia dell’economia dimostra che una volta dati i diritti ai lavoratori, nella prima Rivoluzione industriale, l’economia ha fatto un balzo in avanti; abolita la schiavitù, lo stesso”, conclude Biggeri.