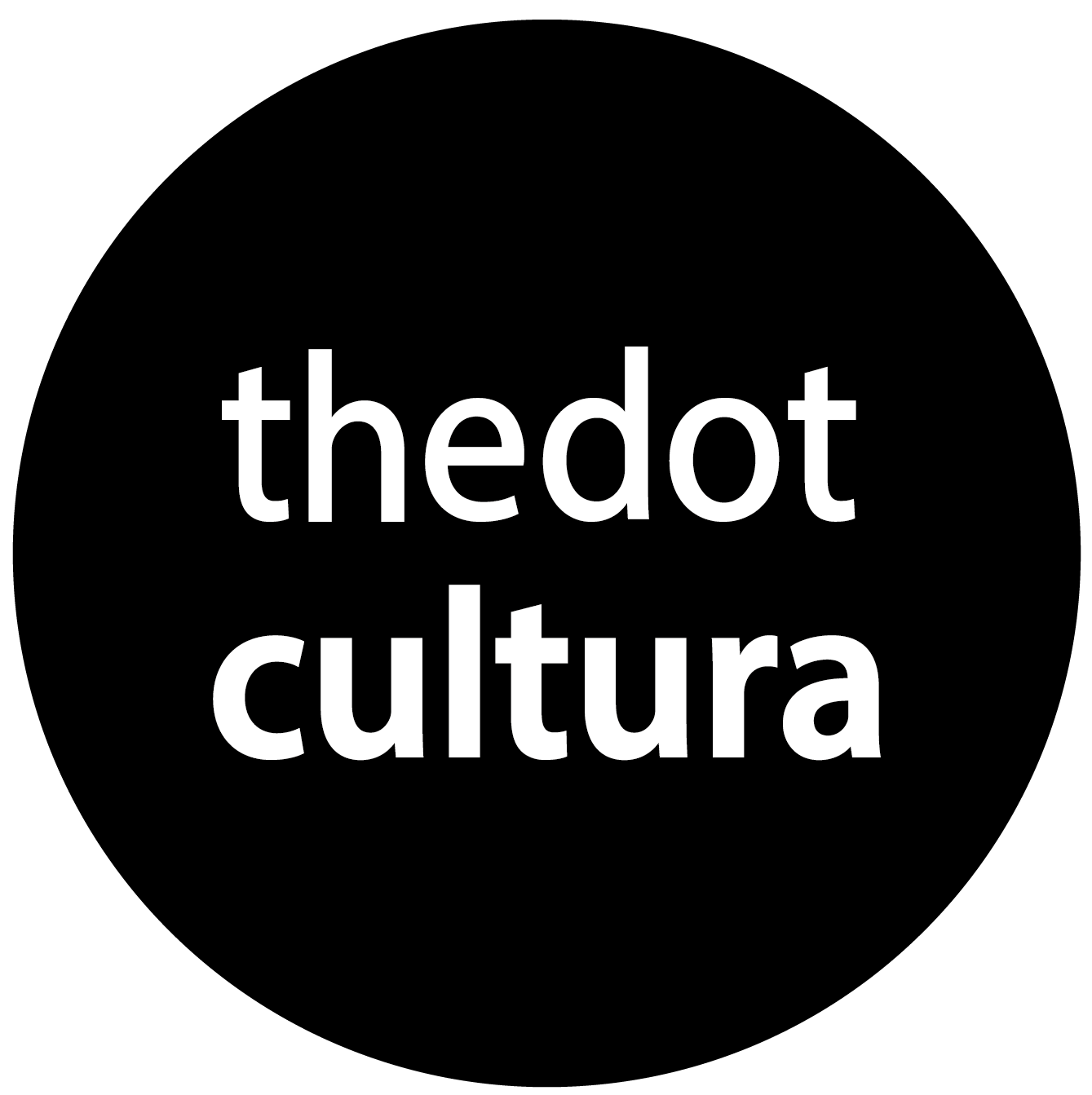Firenze – La pandemia ha segnato anche il mercato fondiario, ma pur riducendo in maniera significativa l’attività di compravendita, non ha influenzato in modo particolarmente pesante le quotazioni dei terreni. Anche per quanto riguarda il mercato degli affitti, l’emergenza sanitaria sembra non aver inciso in maniera sostanziale, con effetti abbastanza circoscritti ad alcuni comparti che hanno presentato un’attività generalmente in flessione, come nel caso della floricoltura, viticoltura e agriturismo, e una tendenza al ribasso dei canoni, dovuta al crollo dei consumi e alla chiusura del canale Horeca.
Sono questi, in estrema sintesi, i risultati emersi dall’indagine annuale sul mercato fondiario e degli affitti in Italia, svolta dal Crea Politiche e Bioeconomia*, curata dai ricercatori delle sedi regionali del CREA Politiche e Bioeconomia, con il supporto del CONAF (Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali). Nel complesso, gli effetti del Covid sono stati meno gravi del previsto, grazie alla ripresa delle attività di compravendita nella seconda metà dell’anno, che è riuscita a compensare, seppure non pienamente, la flessione del primo semestre.
Mercato fondiario – La sintesi dei risultati per quanto riguarda il mercato fondiario, è affidata ad Andrea Povellato (CREA-PB), che nella nota segnala “una significativa contrazione dell’attività di compravendita, ma senza particolari conseguenze sul fronte delle quotazioni dei terreni”.
Tirndo le fila, nel 2020 il prezzo dei terreni agricoli è rimasto stazionario (-0,1% sul 2019) con flessioni generalizzate soltanto nelle regioni del Nord-Est, dove l’aggiustamento delle quotazioni prosegue ormai da diversi anni. A subire penalizzazioni più evidenti sono le zone di pianura e in parte collinari: oltre a Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Liguria, dove le contrazioni sono più evidenti, il fenomeno ha interessato anche Toscana, Molise e Campania. Magra consolazione, il confronto con il dato sull’inflazione che tuttavia dà qualche speranza: nel 2020, come si siega nella nota del Crea, “l’indice generale dei prezzi ha presentato un valore negativo (-0,2%), quindi il patrimonio fondiario medio nazionale, in termini reali, è aumentato lievemente (+0,1%), dopo una serie negativa che continuava dal 2007”. Premio di consolazione che tuttavia non può non fare i conti con il dato di fatto che “l’inflazionecon segno negativo segnala una situazione economica generale non certo favorevole”.
Per quanto riguarda gli atti di compravendita e secondo le statistiche rese note dal Consiglio Nazionale del Notariato, il numero delle compravendite riguardanti terreni agricoli, conclusi nel 2020, “è diminuito dell’8,4% rispetto al 2019, invertendo una tendenza positiva che durava dal 2014″. Ancora più accentuata è la riduzione del valore monetario delle transazioni, che si ferma a 4,8 miliardi di euro, come sgnalano gli analisti, un buon -21% rispetto al 2019. A risentirne maggiormente, continua la nota di sintesi, “sono state le contrattazioni per importi superiori ai 100.000 euro, numericamente esigue (7% del totale) ma prevalenti in termini di valore (64%)”.
Il credito per l’acquisto di immobili in agricoltura ha subito, in analogia con quanto detto sopra, una brusca battuta di arresto dopo il recupero avvenuto dal 2012 in poi, secondo i dati della Banca d’Italia. “Le erogazioni pari a 319 milioni di euro (-42% sul 2019) riportano i valori quasi ai minimi storici dell’inizio decennio. La contrazione, ben più significativa della riduzione dell’attività di compravendita in generale, riporta in primo piano il tema della difficoltà di accesso al credito, tante volte denunciato dagli operatori del settore”.
Altro dato, il fatto che gli effetti della pandemia sull’attività di compravendita “sono stati decisamente maggiori nel primo semestre del 2020, come attestato dalle statistiche del Notariato (-29% rispetto allo stesso semestre del 2019, mentre nel secondo semestre si è registrato un +12%)”, mentre nella seconda metà dell’anno, la pur decisa ripresa delle attività mercantili “non è riuscita a compensare pienamente la flessione del primo semestre”.
Fra le ragioni del rallentamento delle compravendite, l’analisi Crea indica in alcuni casi, a seconda dell’indirizzo produttivo delle aziende, “la mancanza di liquidità”, soprattutto per le produzioni più legate agli effetti delle chiusure, come floricoltura, viticoltura, agriturismo. “Per converso, si segnala anche un effetto contrario laddove la mancanza di liquidità e situazioni aziendali particolarmente fragili hanno spinto alcuni operatori a vendere per consentire di superare un momento finanziariamente molto difficile. In sostanza, da un lato sembra si sia accelerato il processo di dismissione da parte di operatori a bassa redditività, mentre dall’altro lato gli investitori più dinamici restano in attesa di tempi migliori“. Sebbene continui una diffusa percezione di incertezza, segnalano dal Crea, gli operatori hanno espresso “un cauto ottimismo sulla capacità del settore di cogliere i segnali di ripresa, che potrebbero riverberarsi anche sul mercato fondiario. Il PNRR potrebbe essere di aiuto in questo senso, mentre permangono dubbi sugli effetti incerti della riforma della PAC”.
Il mercato degli affitti nel 2020. Per quanto riguarda il mercato degli affitti, la sintesi affidata a Davide Longhitano (CREA-PB), segnala che anche in questo settore “l’emergenza sanitaria sembra non aver inciso in maniera sostanziale”. Gli effetti, che pur ci sono stati, sono rimasti piuttosto circoscritti ad alcuni comparti “che hanno presentato un’attività generalmente in flessione, come nel caso della floricoltura, viticoltura e agriturismo, e una tendenza al ribasso dei canoni, dovuta al crollo dei consumi e alla chiusura del canale Horeca”. D’altra parte, è stata proprio l’incertezza legata alla pandemia a indurre molti “operatori a rivolgersi all’affitto piuttosto che optare per l’acquisto di nuovi terreni”. Inoltre, la crisi di liquidità manifestatasi in alcuni comparti ha portato a diluire nel tempo il pagamento dei canoni d’affitto.
L’istituto dell’affitto sembrerebbe così continuare a rappresentare il principale strumento a disposizione degli imprenditori per ampliare le proprie superfici aziendali, come più volte emerso anche dalle statistiche ufficiali. “Considerando l’ultima Indagine sulla struttura delle aziende agricole dell’ISTAT disponibile, nel 2016, la superficie in affitto – comprensiva degli usi gratuiti – in Italia ammontava a circa 5,7 milioni di ettari incidendo su quasi la metà della SAU totale . Da notare, in particolare, come oltre i due terzi della SAU in affitto si concentri tra le aziende specializzate in seminativi e l’allevamento di erbivori, seguite da quelle specializzate in colture permanenti e a orientamento misto”.
La domanda nel 2020 continua ad essere attiva soprattutto per i terreni vocati a colture di pregio, come i vigneti a denominazione, mentre l’offerta si alza nelle zone più marginali e meno vocate all’agricoltura. La richiesta di terra in affitto è da scriversi in massima parte a giovani agricoltori e grandi investitori provenienti anche da altri settori, come nel caso, spiega la nota, “di seminativi da destinare a colture agroenergetiche”. L’offerta vede in primo piano soprattutto agricoltori che si staccano dal settore per ragioni economiche o per raggiunti limiti di età. “Complessivamente il volume degli affitti è rimasto abbastanza stabile, così come i canoni che si sono mantenuti sui livelli degli ultimi anni – si legge nella nota – si segnala infatti una maggiore propensione al rinnovo dei contratti in affitto piuttosto che alla stipula di nuove contrattazioni, quasi sempre senza modificare l’importo del canone, per via della proroga concessa ai Programmi di Sviluppo Rurale. La scadenza dei contratti di affitto rimane di fatto tradizionalmente collegata alle politiche comunitarie”.
Per quanto riguarda la tipologia degli accordi, per la maggior parte i contratti di affitto sono regolarizzati secondo accordi in deroga ai sensi dell’art. 45 della legge 203/1982, mentre restano, seppure marginalmente, forme contrattuali atipiche come gli accordi verbali, specie nelle zone più interne e montane.
Seguendo la distribuzione geografica, la domanda tende a prevalere sull’offerta nelle regioni settentrionali, “specie nel caso di terreni destinati a produzioni a denominazione con canoni che seppur stabili, si mantengono su livelli medio alti”. Addirittura si riscontrano incrementi sebbene non diffusi in Lombardia, nel caso di rinnovi contrattuali legati all’aumento di domanda da parte dei giovani, oltre che alla presenza diffusa di impianti di agroenergie (biogas) e alla consueta richiesta per la gestione dei reflui di origine zootecnica. In Veneto emerge un sostanziale un assestamento dei canoni per i vigneti rispetto al passato. Le regioni centrali accusano maggiormente l’effetto pandemico, con la sostanziale immobilità del mercato degli affitti, pochi contratti registrati soprattutto in capo ai grandi investitori. Situazione stazionaria in meridione, sebbene “si continui a rilevare una maggiore attitudine alla regolarizzazione dei contratti d’affitto anche nel caso di quelli stagionali, soprattutto per ottenere i requisiti necessari per accedere ai finanziamenti pubblici”.
* Il Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia effettua fin dagli anni Cinquanta una Indagine annuale sul mercato fondiario, i cui principali risultati vengono pubblicati in un capitolo dell’Annuario dell’agricoltura italiana. L’indagine consente di fornire una sintesi dettagliata dell’andamento generale del mercato fondiario attraverso l’elaborazione di prezzi medi della terra e indici su base regionale. I valori così ottenuti sono da considerarsi indicativi dell’evoluzione in atto nel mercato fondiario. Nel 1994 si è proceduto ad una revisione del sistema di rilevazione che, tra l’altro, ha consentito di creare una Banca dati territoriale dei valori fondiari a partire dal 1992. All’indagine partecipano le Unità Organizzative del Centro di ricerca a livello regionale, coordinate per questa attività da Andrea Povellato della Unità Organizzativa del Veneto.
Foto interna : CREA Politiche e Bioeconomia, ufficio stampa
Foto copertina: Luca Grillandini