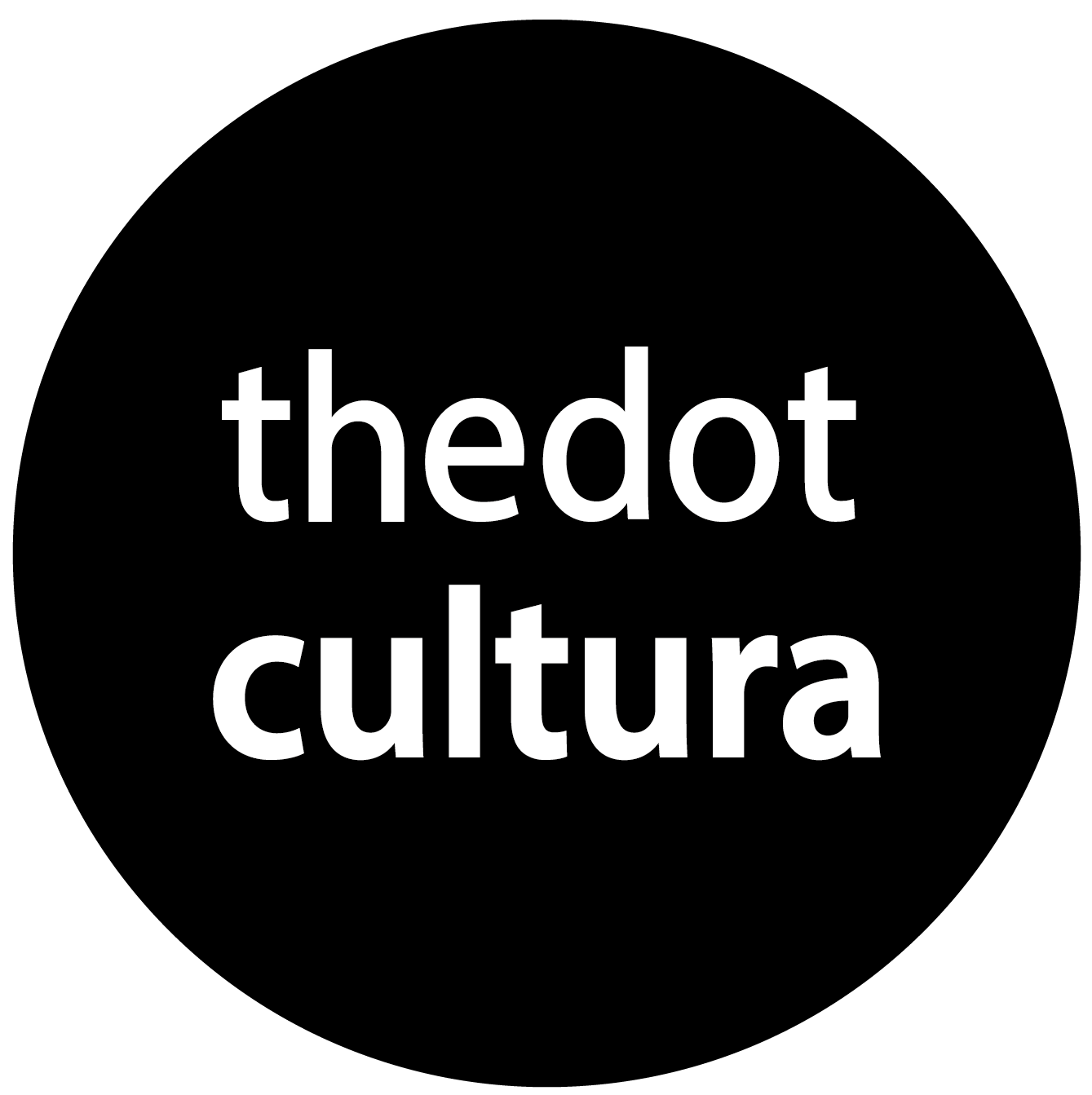Firenze – Questione di punti di vista. Il pubblico fiorentino ha accolto con favore unanime la prima del Prigioniero di Luigi Dallapiccola, quarta opera del cartellone dell’81° Maggio Musicale, con la regia di Virgilio Sieni, e ha invece manifestato in parte un certo dissenso per l’interpretazione che lo stesso regista ha dato della seconda opera in programma, i Quattro pezzi sacri di Giuseppe Verdi.
Eppure, l’impatto di quest’ultima è stato più forte ed emozionante della prima parte dello spettacolo. Forse perché le visioni messe in scena da Sieni fanno parte della nostra angoscia quotidiana, mentre il suo Cristo torturato fisicamente e moralmente dal Grande Inquisitore è un incubo proiettato nel passato. Questione di punti di vista.
Intanto però non rinunciate al momento nel quale si alza il sipario subito dopo l’intervallo fra le due opere. Sul fondo, sugli alti gradini, uomini e donne del coro diretto da Lorenzo Fratini, tutti vestiti di un bianco elettrico, reso ancora più aggressivo dalla luce potente. Davanti a loro uomini e donne con la pelle color mattone sporco, uomini ridotti allo stadio primordiale dell’umanità, costretti a cercare cibo nei cassonetti. Intrecciano figure, movimenti, gesti che esprimono sofferenza, angoscia, ricerca vana di calore e conforto.
I bianchi porgono le braccia, ma sono lontani, molto lontani. Intonano l’Ave Maria, lo Stabat Mater, le Laudi alla Vergine e il Te Deum, massa ordinata, disciplinata, compatta: l’umanità civile e realizzata che ringrazia Dio per i doni ricevuti. Di fronte il gruppo in movimento angoscioso, i derelitti. Nelle preghiere si parla di loro, non dei soddisfatti oranti.
Alla fine si produce una sorta di scivolamento semantico: i veri interpreti e destinatari del canto sacro, del soccorso e della consolazione, che non arrivano, sono proprio quei personaggi che ad alcuni sono apparsi come una arbitraria superfetazione teatrale.
Il contrasto tocca invece i nervi scoperti di questo momento storico. Quei cristi nudi colorati di rosso sono gli sventurati che ogni giorno bussano alle nostre porte, usando tutti i mezzi più o meno rudimentali per fuggire dalla fame e dalla violenza.
Tornando al Prigioniero di Dallapiccola, capolavoro artistico del secondo dopoguerra, di cui conserva tutto il senso del tragico e dell’essenza fredda e implacabile della malvagità umana, si comprende allora l’intero concetto registico e coreografico di Sieni: “L’uomo sopraffà l’uomo e in questo spazio indicibile si assiste all’annientamento di un corpo, allo schiacciamento dell’anima”, scrive l’artista nella sue note di regia.
Ci troviamo in un contesto storicamente determinato. Le guerre di religione dividono per secoli i popoli europei, producono le più crudeli e raffinate forme di tortura per soffocare il grido di libertà della persona che ha preso coscienza di se stesso e del potere che lo vuole annientare. Il torturatore del corpo, il carceriere, si identifica con il torturatore dello spirito, il grande inquisitore e tutti e due sono strumenti del potere assoluto che è quello della morte: “Ad un tratto non è più Re Filippo che mi fissa, è la Morte!”, piange la madre di tutti i figli vittime innocenti.
Un’umanità dolente accompagna e sottolinea l’agonia di un uomo ridotto a un Cristo flagellato, al quale resta solo una flebile speranza in una salvezza che potrebbe arrivare dall’esterno. Ma l’accendere quella speranza da parte degli aguzzini è solo l’ultima più raffinata forma di tortura. La via della fuga porta alla morte, unica forma di salvezza dalla sofferenza concessa.
Sieni rappresenta visivamente i passaggi drammatici della mente del prigioniero con straordinari effetti luminosi e fisici – luce, spettri aloni, nebulose – dietro un sipario opaco, lo stesso che ha usato in una delle sue ultime creazioni, il Petruska di Strawinsky. L’effetto algido e tagliente del linguaggio dodecafonico del Prigioniero diventa ancora più potente attraverso il contrasto fra il corpo martoriato del prigioniero e dei sui compagni di sventura e la losca semplicità delle vesti dei carnefici e delle iene umane che li accompagnano.
“Un uomo ammutolito dall’aver visto prima la luce nello slancio umanissimo della speranza e poi la catastrofe, nella caduta senza spazio che è la perdita della speranza – ancora Sieni – il prigioniero, così come il profugo cerca un luogo “gentile” che possa accoglierlo, determinandolo come uomo che degnamente abita il mondo”. Il grido eterno dell’umanità sofferente è dunque il filo che lega le due opere che segnano il debutto registico del coreografo fiorentino.
Bravissimi i cantanti del Prigioniero alle prese con una partitura complessa. Così come il Coro del Maggio, l’orchestra diretta da Michael Boder, i danzatori della Compagnia di Sieni per uno spettacolo che onora, per artisti e interpretazioni, un festival di alta qualità.