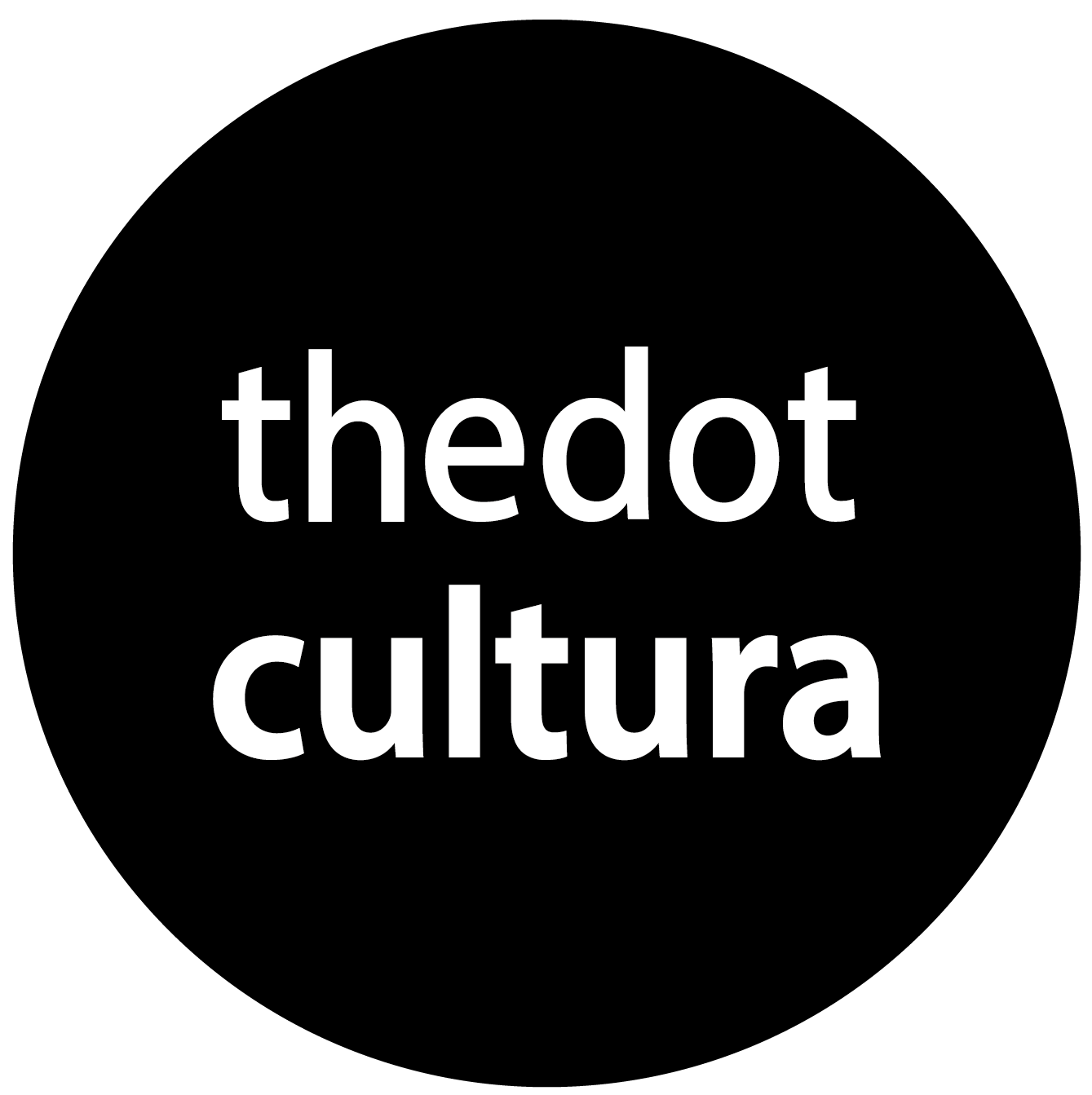Violenza, repressione, soluzioni. Il grande tema della violenza, balzato agli onori delle cronache, è stato al centro della riflessione aperta dalla Fondazione Fratelli Rosselli, che ha organizzato un incontro, tenutosi ieri a Firenze. Prestigioso il palco, che ha visto insieme, oltre al presidente Valdo Spini che ha fatto gli onori di casa e introdotto il tema, il sociologo Marco Bontempi, il professore della Cattolica Vittorio Emanule Parsi, Conchita Sannino giornalista di Repubblica e la nota scrittrice, studiosa, saggista Dacia Maraini.
” La relazione del Censis del 2018 sottolineava che la società italiana era piena di rancore – ricorda il presidente Spini aprendo il dibattito – a ciò si è aggiunto il covid, che ha allentato i legami sociali, in particolare per giovani e giovanissimi. Dovremmo quindi riqualificare qualche elemento di cura, in quanto, a mio parere, ci giochiamo una generazione di giovani, anzi di giovanissimi, in particolare in certe aree e del paese. Per cercare di recuperarli, serve sicuramente la certezza della pena, ma è il tema del recupero dell’istruzione a essere fondamentale, oltre alla ricostruzione di un tessuto di attività che siano veramente competitive rispetto alla criminalità, ma anche rispetto al disgusto, al disprezzo nei confronti della legalità, all’affermaizone di se stessi attraverso la violenza. La settimana scorsa, un bollettino di guerra. Dai processi in corso, fino allo stupro di gruppo , atti pepretrati da giovanissimi che spesso sembra non incorrano in sanzioni sociali vere e proprie, che vengono prima della sanzione penale. Anzi in certi ambienti vengono visti come affermazione di se stessi attraveso la violenza. Dobbiamo creare un tessuto di attività alternative ed è un processo molto lungo”.
A proposito degli ultimi fatti di cronaca, riferendosi alla “stesa” come viene chiamato il blitz di un gruppo di criminali travisati che si inoltrano nelle strade a bordo di motociclette sparando in tutte le direzioni senza obiettivi precisi, “Il raid criminale di questa notte – dice Spini – a Caivano dimostra quanto sarà lunga e difficile la battaglia per espellere la violenza da varie aree del nostro paese. Su questo tema l’impegno dovrà essere delle istituzioni ma molto importante il ruolo della società civile e quindi delle Fondazioni e Istituzioni chiamate a operare sulle cause più profonde della violenza che si è diffusa in vari settori del nostro paese. Ecco perché una Fondazione come quella del socialismo liberale intitolata ai fratelli Rosselli vuole richiamare l’attenzione sui problemi della coesione sociale e culturale del paese proprio come antidoto agli elementi di rottura delle regole del vivere civile cui assistiamo con preoccupazione”.
Conclude Spini: “In altri tempi c’erano molti filtri. I circoli e le sezioni dei partiti, spariti. I consigli di quartiere: emblematica a questo poposotio, la vicenda del Quartiere 1, a Firenze, ora commissariato. A volte, le uniche realtà, come si vede in Campania, che cercano di arginare il disagio rimanendo sul territorio sono i preti. La società civile e politica deve porsi il problema. Un problema sottovalutato dalla sinistra, che non si curava della sicurezza ritenendolo un aspetto più incline alla repressione, ma dava attenzione ai diritti civili e sociali. Come se i due aspetti non fossero legati a doppio giro”. .
E’ con Conchita Sannino che si arriva al cuore del tema violenza, subito, senza mediazioni. La grande firma di Repubblica, autrice di servizi che strappano dall’anonimato, dall’invisibilità intere generazioni di ragazzi, adolescenti bambini o poco più di tali, a Napoli dove vive e lavora, ci fa toccare subito nella sua crudezza il problema dei minori, quello che ora chiamiamo il fenomeno delle gang. E racconta una storia che ha risvolti antichi e mai risolti, ovvro quella di un abbandno, di una sottovalutaizone, di una cancellazione. Protagonista, lo Stato o meglio una classe politica senza colore, che ha condannato intere generazioni alla peggiore delle condanne, l’irrilevanza.
Ma tutto ciò ha uno scotto a pagare, e il conto che la società presenta è quello del deserto educativo, di “genitori che non sanno essere genitori, che sono a loro volta stati allevati da famiglie non famiglie”, in un protrarsi dell’assenza, dell’indifferenza e dela sottovalutazione resa plasticamente anche dalla fisicità delle zone in cui questa umanità senza nome è relegata: zone non zone, con superbe cattedrali nel deserto, costituite da strutture cui hanno messo mano archistar internazionali e assenza totale di collegamenti col resto dell’umanità; né tram, né bus affidabili, né pullman o qualche straccio di trasporto pubblico efficiente, umano, che possa traghettare le persone verso il resto della metropoli. Un problema di abbandono che si condensa nelle parole, riferite da Sannino, di uno dei preti che contendono quotidianamente spazi, persone e anime alla crminalità diffusa, “in trent’anni neppure una pensilina per evitare agli anziani di aspettare il tram alle intemperie abbiamo avuto”, parole terribili, che ne celano molte altre: e le scuole? E le palestre? E i cinema? E i teatri? e le bilbioteche? E tutto ciò che rende l’esistenza capace di autodeterminarsi? In altre parole, e la cultura? Ma soprattutto, e qui si entra in un lungo, complesso discorso che meriterebbe un approfondimento di molti seminari, e il lavoro? Tutto riassumibile in un unica domanda: e l’alternativa?
Se questo tuffo senza rete nella realtà quotidiana della violenza sociale conseguente all’invisibilità di interi territori su cui la politica non ammette l’enorme responsabilità, mette i brividi, fa un po’ sorridere il pur dovuto e necessario tentativo di intervenire con le forze dell’ordine per ristabilire una legalità che da tempo ormai è diventata opzionale, in zone non solo del Meridione italiano, ma anche delle banlieue delle grandi città del nord (basti pensare a Mlano),
Un tentativo che comunque viene vissuto come una sfida dallo stesso territorio, che, come mette in luce l’intervento del direttore della facoltà di sociologia dell’Università di Firenze Marco Bontempi, è assuefatto a un’ordinaria gestione del quotidiano che ingloba la violenza, in cui è la violenza la regola della normalità. Un’indagine, la sua, che riguarda un concetto che ebbe fortuna in particolare con Galtung, negli anni ’70, e che dà una misura innovativa alla sociologia intera che riflette sulla violenza, ovvero la violenza strutturale. Aggiungiamo: la violenza strutturale del sistema. Nessuno è indenne, nessuno può chiamarsi fuori. Laddove un sistema genera in sé violenza, che significa in buona sostanza creare strutturalmente, per sua natura, sacche anche ampie di disagio, disuguaglianza e ingiustizia sociale , ovvero sofferenza, deprivazione e miseria, la violenza è da considerarsi un prodotto strutturale del sistema. Non solo: è così strutturale, che spesso le persone immerse in questo sistema neppure ritengono di essere in qualche modo “anomale”, ovvero di vivere in una situazione in qualche modo marginale rispetto al resto della società.
Una chiave di lettura che può applicarsi anche alle comunità straniere, anche a casi come quello tristemente famoso dell’omicidio di Saman, giovanissima donna pakistana, da parte del padre e dello zio, in risposta alla sua scelta di innamorarsi di un ragazzo occidentale rifiutando la condizione di sudditanza femminile propria della cultura d’origine. Sottolineando che queste comunità chiuse sono state segnalate recentemente prorio su queste pagine, dal presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri come corpi autonomi, con proprie regole slegate dal contesto del Paese ospitante, l’analisi sociologica del professor Marco Bontempi aiuta in buona sostanza a comprendere il meccanismo della violenza strutturale che, lungi dal giustificare in nome di un presunto relativismo culturale o di ineluttabili dinamiche dovute al destino, atrocità come quelle di Saman o di tanti altri casi che sono avvenuti non solo sul suolo italiano, conduce alla comprensione del fenomeno e al tentativo di soluzione, in una ricerca delle cause per cambiare sia causa che effetto. Del resto, ciò che non possiamo dare per scontato, conclude Bontempi “è la razionalizzazione di tutto il reale”, nel senso che è necessario indagare i fenomeni per come sono, per riuscire a trarre soluzioni.
Ma, al di là delle varie analisi, una parola forte di chiarezza la aggiunge Dacia Maraini, scrittrice nata a Firenze, che porta un contributo sulla volenza di genere. Intanto, un punto deve essere chiaro, dice Maraini: “Le conquiste democratiche e di eguaglianza di genere raggiunte dalla civiltà occidentale sono conquiste dell’umanità e come tali salvaguardate”. Un punto fondamentale, questo messo in luce , perché sottrae le grandi conquiste sociali, la libertà di autodeterminazione delle donne e delle categorie fragili (riferendoci a chi ancora lotta, ad esempio, per potere decidere il proprio orientamento sessuale senza l’imposizione di stigma sociali avvilenti e degradanti) alla relativizzazione del contesto culturale.
Si sappia insomma che chi decide di vivere in Occidente si deve conformare al ripetto dei diritti della persona, e nella persona è compreso il genere femminile. Eppure, il problema degli stupri sta balzando alle prime pagine dei giornali occidentali come una sorta di nuovo territorio per l’affermazione del potere maschile. “Un retaggio antico – dice Maraini – che deriva da logiche arcaiche in cui la conquista del territorio da parte di un popolo rispetto a un altro popolo comprendeva l’appropriazione non solo delle case, delle terre e perché no, degli dèi, ma anche delle donne, considerate nella loro veste di “fattrici”, il che voleva dire, simbolicamente, occupare il futuro dei vinti”.
Una parte del problema dunque risiede nel fatto, sviluppatosi con la fine delle società composte da raccoglitori-cacciatori in cui i ruoli si equivalevano, che il passaggio alla società agricola vede nascere il concetto di proprietà e la differenziazione funzionale dei ruoli uomo-donna, da cui scaturisce (valida per millenni) la concezione della donna come parte della proprietà maschile, alla stregua più o meno, della terra, degli animali, degli schiavi (altra categoria cui è tolta, o dimezzata, l’umanità). Un ritorno in grande stile insomma, negli stupri odierni di gruppo, della concezione “non umana” della donna, e dell’appropriazone “dovuta” per esternare il suo potere sulle “cose”, del maschio.
Una concezione molto rassicurante per i “maschietti” in un’epoca generale di confusione in cui la nota fondamentale sembra esser la paura: paura del presente,dove tutto è precario a cominciare dal lavoro, paura del futuro che ammannisce solo tragedie spaventose come un cambiamento climatico di cui ognuno ha prove concrete sul proprio quotidiano (ultima notizia tragica, le tempeste che hanno fatto mgliaia di morti in Libia) o una guerra non lontana, in altri Paesi anch’essi dimenticati, ma proprio qui, in Europa. Una paura che monta anche nel ceto medio, che ormai vede le sue frange più basse pescare nell’indifferenziato mare del disagio economico, meglio dire povertà. Uno studio recente del comune di Firenze rivela che i prossimo 80enni non avranno casa di proprietà (la precarietà abitativa frastorna anche il Paese di proprietari di case…) e godranno di “pensioni leggere”, delicato eufemismo per dire: faranno lafame e non si potranno curare. Sgombrare il futuro di speranza e consegnare tutto alla paura, fare deserto degli strumenti intepretativi della realtà che solo la cultura può dare, apre senz’altro la strada alla violenza.
Dalla violenza individuale a quella di gruppo, a quella sociale e strutturale insita nel sistema, questa carrellata non può sen’altro tacere della violenza iternazionale, ovvero di ciò che si presenta come “guerra”. Uno dei cavalli dell’Apocalisse, uno dei più temuti dai popoli, uno di quelli che marcia sulle spalle di migliaia o milioni di vittime innocenti, a cui nessuno ha chiesto, nessuno stato, democratico o no, se volessero entrare in guerra. La relazione di Vittorio Emanuele Parsi dell’Università Cattolica di Milano e volto noto ai telespettaori e agli intellettuali non solo italiani, mette in luce alcune dinamiche che riguardano la guerra. Intanto, spiega, “vi è un legame molto forte fra la democrazia e un ordine di valori irrinunciabili, propri di quella parte del mondo, ovvero l’Europa occidentale, che per secoli ha dato forma al resto del globo”. Un’affermazione che ha una sua verità ineliminabile, ma che tuttavia, se vista ad esempio dalla parte del globo dominato dall’influenza cinese, potrebbe sollevare qualche dubbio.
Ma il vero problema è chiedersi se la guerra sia un concetto giustificabile, ovvero, se l’uso della violenza fra Paesi sia giustificabile, o meglio accettabile, come strumento di politica internazionale. Premettendo, come fa il professore, che “la guerra è stata impiegata fino agli ultimi 75 anni” come mezzo di utilizzo normale, bisogna chiedersi quali sono le conseguenze della nuova guerra europea. “Un assalto di fatto proprio al sistema che ha retto per circa 80 anni sul territorio d’Europa”, proprio nella zona che storicamente ha sempre utilizzato la guerra come strumento normale di rapporti fra potenze. Un legame inscindibile con la democrazia e con valori conivisi propri della democrazia, ha fatto sì, dice Parsi, che questo sistema assicurasse circa 80 anni di pace all’Europa.
Da qui, la conseguenza logica: “Non si può considerare alla stessa stregua chi aggredisce uno Stato e chi risponde all’aggressione. E’ necessario distinguere fra aggressione e difesa”. Insomma, declinato in altri termini, la guerra può essere di aggressione o di difesa. E non è la stessa cosa, alla luce di quei principi di democrazia cui si ispira il mondo occidentale, che sprona a difendere la guerra di difesa e condannare quella di offesa. Pena, la perdita di credibilità della stessa democrazia. Ciò indurrebbe a pensare al concetto di violenza “ncessaria”, ovvero, nell’ambito della politica internazionale, di “guerra necessaria”. necessaria per mantenere e difendere quell’ordine di valori democratici cui l’Occidente ha legato la propria identità.
Eppure un tarlo continua a rodere: chi decide quando le condizioni per difendere la guerra, o, più rozzamente, per ritenere una guerra “giusta” tanto da difenderla, avvallarla, rfforzare una parte nei confronti dell’altra, quando dunque, le condizioni si avverano? Un atto di aggressone? Benissimo. Ma una regola per essere regola, deve valere per tutti. Di fronte al genocidio del popolo curdo, per fare un esempio, o alla ribellione palestinese all’occupazione dei propri territori da parte di Israele (esistono anche risoluzioni Onu mai osservate d Israele) , o all’esplosione, a suo tempo, delle rivolte irlandesi contro le occupazioni inglesi, perché gli stati democratici non hanno reagito o non reagiscono? Il dubbio in definitiva è che anche nel gran consesso dei popoli, sia in vigore il principio che Conchita Sannino ha ben delineato nel suo intervento, ovvero quello dell’invisibilità. Ci sono ceti sociali invisibili sul suolo nazionale, europeo e mondiale, ci sono intere popolazioni “invisibili” sul piano internazionale. Ed è questo, forse, uno dei grandi vivai dove la violenza attecchisce, cresce, prospera.
In foto: da sinistra, Valdo Spini, Conchita Sannino, Dacia Maraini