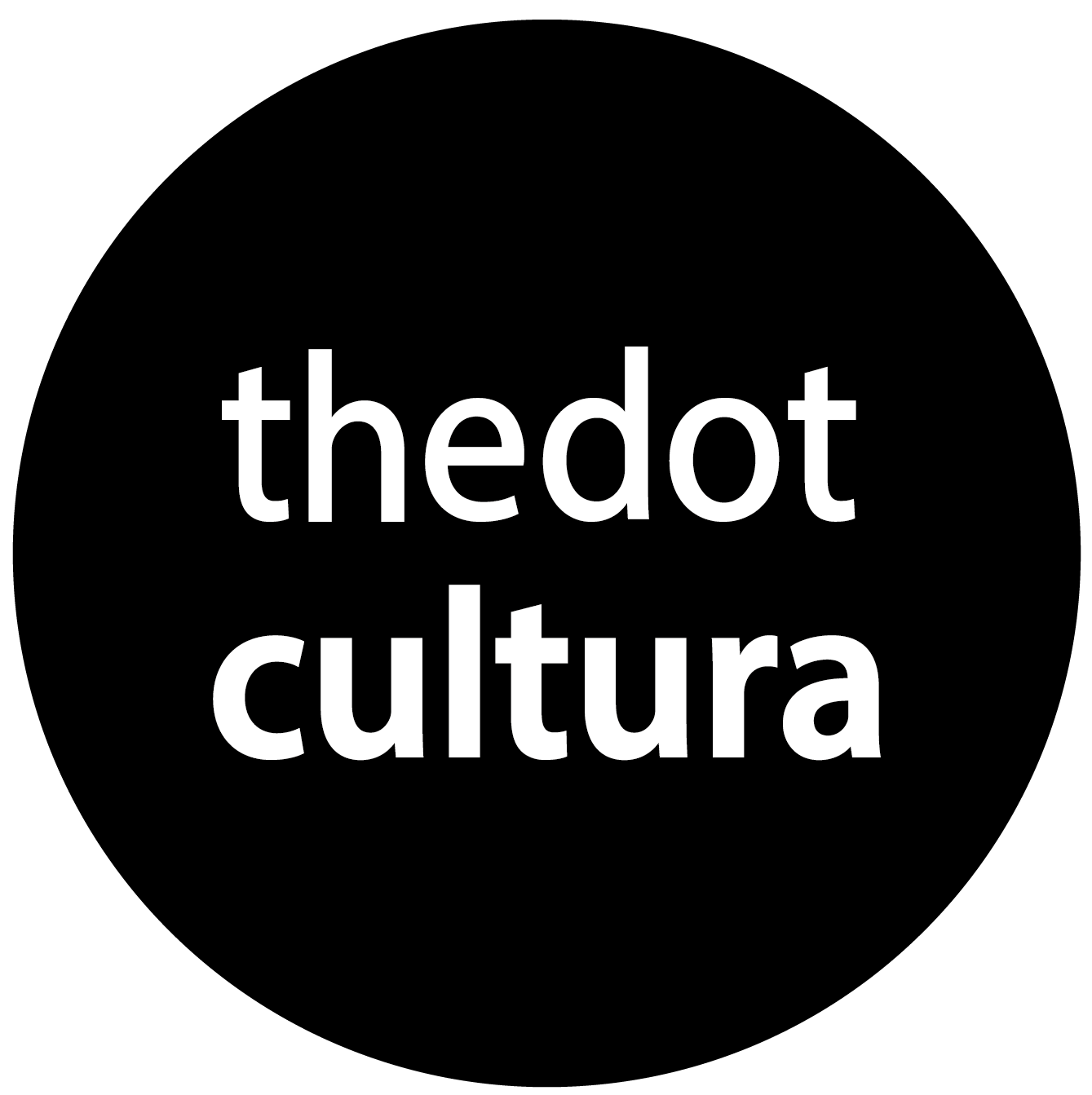Firenze – Intervento a tutto tondo della sezione fiorentina di Italia Nostra. Infatti, la voragine che si è aperta nel tratto del lungarno fiorentino prossimo a Pontevecchio ha indotto l’associazione che si occupa della salvaguardia dei beni ambientali e artistici d’Italia a compiere un vero e proprio studio dell’area, che, oltre a implicazioni idrogeologiche di storica fragilità, impone, per la sua stessa delicatezza, una particolare attenzione sia nell’utilizzo sia nella manutenzione del contesto ambientale. Attenzione e cura, che, conclude Italia Nostra, non sembrano affatto essere state osservate. L’approfondimento che Stamp propone è stato realizzato dal professor Leonardo Rombai, presidente di Italia Nostra Firenze, Mariarita Signorini, presidente di Italia Nostra Toscana, e Mauro Chessa, geologo, membro del direttivo fiorentino dell’associazione.
Il primo dato che balza agli occhi, dicono i tre studiosi, è che a tutt’oggi la causa che ha prodotto lo scoppio del tubo dell’acquedotto e la voragine di Lungarno Torrigiani a Firenze non è chiara. L’effetto catastrofico dello smottamento è stato tuttavia assai ridimensionato”dal muro di contenimento sapientemente costruito, sul fiume, dall’ingegnere architetto Giuseppe Poggi negli anni della Firenze capitale”. Motivo in più dice Italia Nostra, per chiedere legittimamente che il restauro della’area disastrata (“di restauro si deve parlare”) avvenga secondo modalità corrette .
Del resto, il 28 maggio scorso il geologo Nicola Casagli dell’Università di Firenze non escluse, nelle pagine di un quotidiano cittadino, che la rottura del tubo dell’acquedotto” possa essere stata determinata da “una frana già in atto nell’argine”; dubbio che potrebbe essere chiarito con l’aiuto dei dati satellitari.
Ma non è la prima volta che l’area comprendente la collina da San Miniato-San Giorgio a San Niccolò-Costa Scarpuccia e Arno dimostra la sua instabilità, dovuta in buona sostanza alla prevalenza di terreni argilliti che la compongono. Tant’è vero che, ricordano gli apici di Italia Nostra regionale e fiorentina, “l’Atlante delle frane del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze del 2013 vi censisce, cinque estesi movimenti franosi”.
“Innumerevoli sono le testimonianze dei tanti dissesti rovinosi, verificatisi già dal Rinascimento – ricorda Italia Nostra – basti pensare che lo stesso Bernardo Buontalenti, uno degli artisti più importanti e influenti della seconda metà del Cinquecento e personaggio chiave dell’epoca del manierismo fiorentino, rimase illeso da ragazzo da una frana in Costa San Giorgio che travolse la sua casa e sterminò la sua famiglia. E forse si trattò della stessa frana, quella del 12 novembre 1547, in cui rovinò l’abitazione della famiglia Nasi, ricchi mercanti fiorentini, tra le cui macerie fu ritrovata la celebre Madonna del Cardellino di Raffaello, smembrata in diciassette frammenti, che furono recuperati e affidati al restauro (forse incaricando Michele di Ridolfo del Ghirlandaio)”.
Frane che continuarono a prodursi fin nell’età moderna, soprattutto lungo Via Bardi e intorno alla chiesa di Santa Lucia dei Magnoli detta significativamente “delle Rovinate”,” tanto che il granduca Cosimo I nell’ottobre 1565 arrivò addirittura a vietare – come recita una lapide – di costruire nuove abitazioni nell’area”. Lo stesso Poggi era ben consapevole della fragilità del sistema della collina, tant’è vero, come ricorda Italia Nostra, che realizzò il riassetto del versante di Piazzale Michelangelo tramite l’articolato complesso delle Rampe che assolveva dichiaratamente alla duplice funzione di riequilibrio del rilievo e di elemento di raccordo fra il Piazzale e i Lungarni.
E tuttavia, sia nel caso che il movimento franoso mai domo sia intervenuto nell’avverarsi dello scoppio della tubazione, sia in quello, che vedrebbe la conduttura dell’acqua scoppiata per cause proprie, la voragine fiorentina in Lungarno Serristori non sarebbe in ogni caso un incidente. Non lo sarebbe, dice l’associazione, in quanto nel primo caso la consapevolezza della fragilità idrogeologica del territorio avrebbe dovuto indurre a un monitoraggio attento e continuo che si sarebbe dovuto riverberare anche negli interventi dell’area, nel secondo caso “perché questi episodi sono frequenti lungo i vetusti acquedotti italiani, anche se molti non fanno notizia”. E si torna dunque al problema fondamentale della gestione idrica italiana, dice l’associazione ambientalista, “figlia naturale della normativa che regola la gestione della risorsa idrica e la rende un affare assai lucroso”.
Di fatto, ricorda Italia Nostra, i gestori vendono l’erogazione dell’acqua, così come misurata ai contatori degli utenti, ma non hanno “alcun interesse a riguardo della manutenzione della rete, che non è di loro proprietà”. Cosa succede?Publiacqua, ad esempio, “immette nella rete il 51% in più dell’acqua che arriva ai contatori: una parte di questo spreco è dovuto ai processi di depurazione e alle manutenzioni, ma la maggior parte se ne va nelle perdite. I criteri manageriali dei gestori sono manifestamente – e legalmente – speculativi: i ricavi tariffari di Publiacqua sono aumentati vertiginosamente e per contro al 2014 ha realizzato 69 milioni di investimenti in meno di quanto previsto dal Piano d’ambito e da quello tariffario”.
Per fare qualche conto, incalza Italia Nostra, a Firenze, e su tutta la rete gestita da Publiacqua, “ogni utente paga circa quattro volte la tariffa richiesta a un milanese, e non deve preoccuparsi solo delle perdite ma anche dei 225 Km di condotte in amianto, di una depurazione fortemente insufficiente, tanto da rischiare sanzioni europee, e persino della gestione creativa delle bollette: comitati e cittadini hanno denunciato fatture illegittime a carico di oltre 39.000 utenti. Publiacqua eroga soprattutto utili per il gestore: è stata costituita nel 2000 per iniziativa di vari comuni, nel 2006 è stato individuato un partner privato composto da aziende pubbliche e private, fra le quali Acea S.p.A. che detiene il 40% del capitale sociale. Nell’ultimo anno senza i privati, il bilancio si era chiuso sostanzialmente in pareggio, negli anni seguenti si è registrata una progressione degli utili netti fino ad oltre 30 milioni di euro nel 2013 (ultimo bilancio noto). Il futuro sarà ancor più beffardo per il povero utente: nell’aprile 2014 l’Autorità Idrica Toscana ha approvato il piano economico finanziario valido fino al 2021, secondo il quale i ricavi di Publiacqua sono destinati a crescere del 61%, con un aumento solo del 3% dei costi mentre gli investimenti registreranno addirittura un calo del 51%”.
Ma se il regime è legalmente speculativo, conclude Italia Nostra, il nostro appello riguarda sia l’attenzione per un territorio fragile ma dalla forte memoria artistica e storica, sia la necessità da parte di Publiacqua di realizzare un vero rinnovo del sistema delle tubazioni e distribuzione dell’acqua, con accorgimenti tecnologici ancor più necessari vista la problematicità dell’assetto idrogeologico in cui viene a operare.
Foto: spostamento del muro su Lungarno Torrigiani – da pagina Fb di Mariarita Signorini-Mauro Chessa