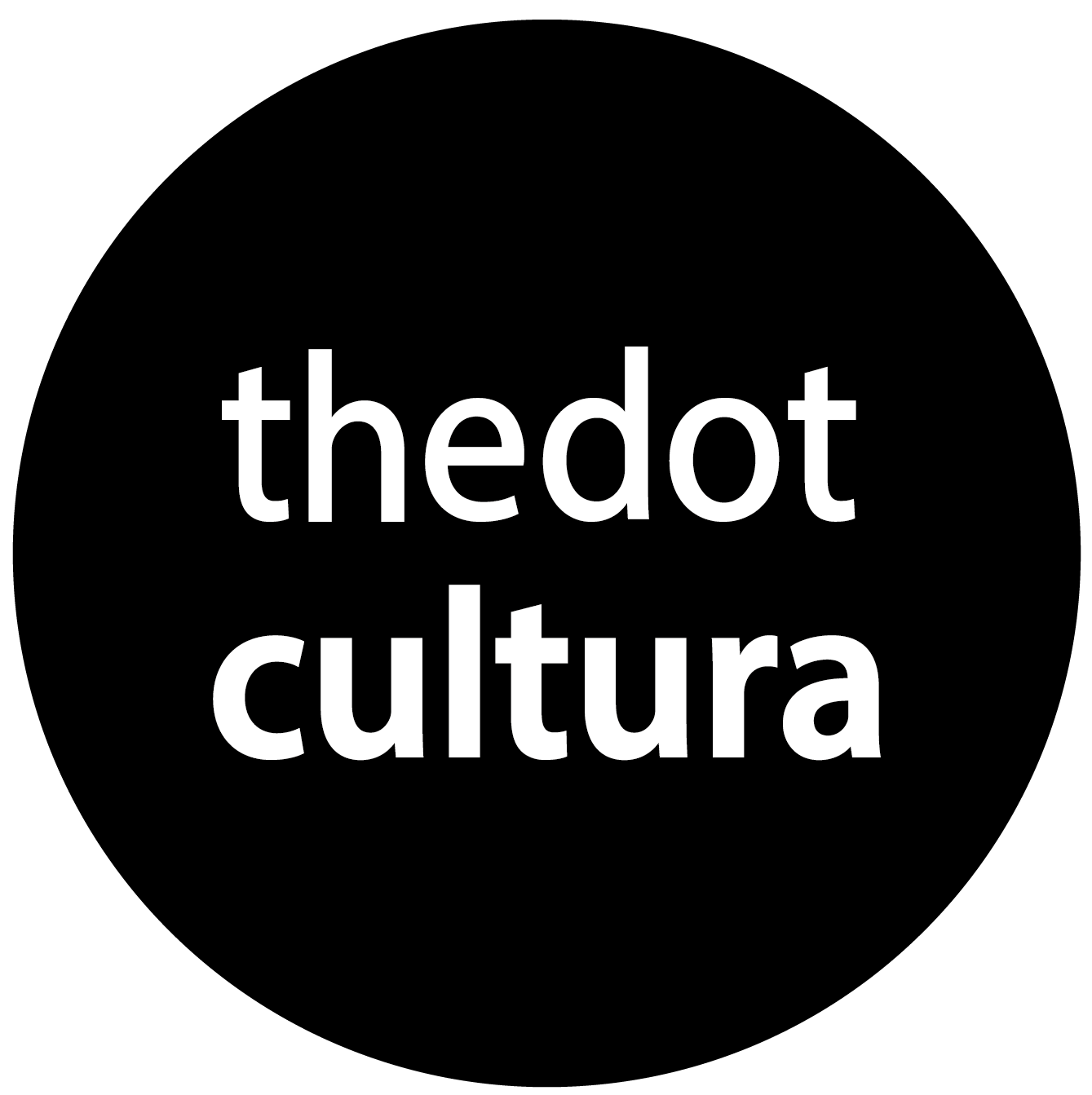Firenze – Grandi movimenti nel sistema internazionale dei media. Google e Facebook hanno deciso dei cambiamenti che tentano di allentare i conflitto con i grandi gruppi editoriali che producono informazione. Google ha reso disponibili agli editori i dati degli accessi ai siti gratuiti attraverso il motore di ricerca per aiutarli a vendere gli abbonamenti, e Facebook ha cominciato a pubblicare i marchi degli editori in modo da rendere visibile la fonte delle notizie.
“E’ come se il lupo aiutasse la pecora a nutrirsi”, è il commento di chi si oppone allo strapotere mediatico dei due giganti riportato dal settimanale britannico The Economist molto attento su quanto sta accadendo nel mondo dell’informazione. Una delle ultime copertine dell’autorevole magazine finanziario poneva una questione cruciale dei nostri tempi: “I social media minacciano la democrazia?”.
La domanda è tutt’altro che accademica visto che Facebook ha ammesso che prima e dopo le elezioni americane 146 milioni di utenti sono stati toccati dal flusso di false informazioni provenienti dalla Russia e Twitter che gli account riferibili a operazioni di disinformazione di origine russa sono stati 36.746: “Ben lungi dal portare chiarezza, i social media hanno sparso veleno”, commenta l’Economist.
La questione del Russiagate ripropone con drammaticità la questione di come difendersi dalle fakenews, le notizie false, taroccate, mascherate da verisimiglianza. Anche a Firenze se n’è parlato nella sede del Consolato americano che ha ospitato un incontro con Maksymilian (‘Maks’) Czuperski , direttore del Digital Forensic Research Lab e consulente speciale del Presidente dell’ Atlantic Council.
Il problema si può inquadrare in questi termini. Teoricamente con uno smart si può avere accesso a tutta l’informazione che viene prodotta nel mondo senza interruzione, una tale massa destinata a crescere che viene assorbita dall’individuo in modo passivo. Cosa fare dunque per aiutarlo a selezionare le notizie, distinguerle in modo critico e dunque a respingere le bugie e le suggestioni ingannevoli?
“Occorre fornire gli strumenti per distinguere le informazioni”, risponde l’esperto americano che ha fornito alcuni esempi efficaci dell’attività di controinformazione del laboratorio che dirige. Fra l’altro ha raccontato il modo con il quale è stata smascherata la versione di Vladimir Putin secondo il quale i ribelli filorussi ucraini non avevano nulla a che fare con l’Armata rossa. Grazie a un selfie improvvidamente scattato da un soldato in territorio ucraino occupato e postato su Facebook si è potuto ricostruire la sua identità, la sua carriera professionale nell’esercito russo, il luogo dove si trovava, i dettagli del mascheramento da volontario ucraino.
Cosa fare dunque se la menzogna è così vasta ed estesa e se è sostenuta da uno stato? “Empower the citizens”, rafforzare la cultura digitale dei cittadini, fornirgli un metodo, fare in modo che non dipenda dalla fonte ufficiale, aiutarlo a inserire l’informazione in un contesto più ampio: “Occorre responsabilizzare soprattutto i giovani perché la società sia resiliente, in grado si stare al passo con l’enorme crescita delle potenzialità della rete”, ha concluso Czuperski.
Le sue conclusioni si scontrano tuttavia con alcuni interrogativi che sono emersi durante la discussione che ha seguito la relazione dell’ospite Usa. Gli utenti hanno solo teoricamente la possibilità di utilizzare i grandi strumenti tecnologici che permettono di smascherare le menzogne, data la quantità di informazioni che ricevono e il tempo a disposizione per analizzarle anche se fanno del loro meglio. Uno studio recente ha messo in luce che un utente americano o europeo tocca il suo smart in media 2.600 volte al giorno.
Occorrerebbe dunque un’autorità indipendente che filtra, distingue e aiuta a correggere le informazioni false. Ma è inutile andare a cercare chissà dove questa autorità perché la società dispone già di uno strumento che la difende dai mestatori e dagli impostori: i giornalisti e la loro deontologia professionale.
La vera soluzione efficace appare quella di ricostruire un sistema di informazione basato su professionisti competenti, seri e leali “al servizio dei lettori e non del potere” come si diceva una volta. Finora si è lasciato che l’informazione diventasse una “commodity” una materia prima senza valore, o che il valore le fosse dato solo dalle logiche commerciali e dagli esperti di pubbliche relazioni. Il risultato è stata l’esplosione della fakenews.