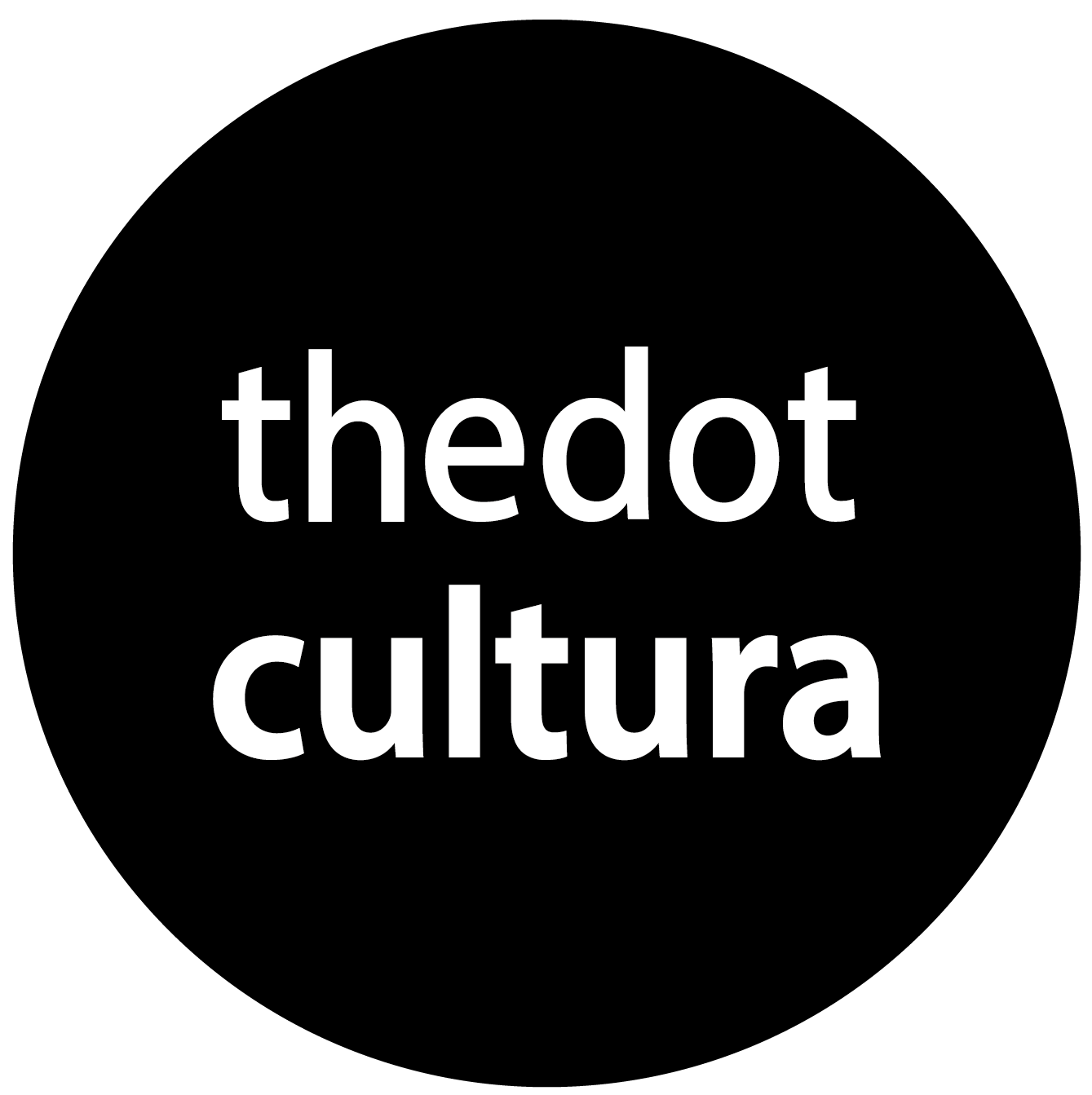Israele non sarebbe stata in grado alla prima incursione di infliggere all’Iran l’incapacità di reagire e il primo obiettivo della ritorsione iraniana sarebbe stato la V Flotta americana nel Golfo Persico. Le perdite imprevedibili, ma presumibilmente assai pesanti e devastanti per l’Amministrazione militare e civile americana nonché per il Presidente a pochi mesi dalle elezioni, non sarebbero state tollerate dall’opinione pubblica americana, non in animo di nuove guerre.
Obama perseguiva, e persegue, l’obiettivo di fermare, con le sanzioni economiche (cfr. “Stamptoscana” del 5 aprile) e la diplomazia internazionale, l’ipotetica, ma probabile intenzione iraniana di dotarsi l’arma atomica. Netanyahu aveva nutrito la speranza che fosse eletto alla presidenza Mitt Romney che in campagna elettorale andava dichiarando di condividere la richiesta del primo ministro israeliano di indicare una ‘linea rossa’, oltre la quale gli Stati Uniti avrebbero partecipato a un offensiva militare, che Obama si rifiutava di tracciare. Egli è stato rieletto e di preparazioni belliche contro l’Iran da allora nella stampa non si scrive più. Il dispetto per l’affermazione di Obama fra gli interventisti nostrani (si legga Fiamma Nierenstain in “Il Giornale” del giorno seguente le elezioni e nel medesimo giorno sullo stesso quotidiano la spiegazione «Perché Mitt Romnei sarebbe un presidente migliore») riflette la delusione del premier israeliano.
La divergenza fra il governo israeliano e l’amministrazione Usa –manifesta dal dicembre 2011 per il contrasto sui provvedimenti contro l’Iran, ma evidente già dal primo anno dalla prima magistratura di Obama per l’insoluta questione palestinese– non è l’unico motivo che ha impedito Netanyahu di bombardare gli impianti nucleari iraniani. Infatti il governo di coalizione israeliano era spaccato. Non approvava l’intervento la metà del gabinetto, compreso il ministro degli Interni Eli Yishai, capo dello Shas, partito religioso determinante nella coalizione governativa. Contrario anche Benny Gantz capo dello Stato Maggiore (“Stamptoscana” del 20 giugno) il cui consenso di norma è necessario per le operazioni di guerra. Contro l’attacco (strike) all’Iran si sono dichiarati, «barriera insuperabile» (“Haaretz” del 21 agosto) per Netanyahu, anche Rabbi Ovadia Josef, fondatore, tuttora guida spirituale dello Shas e Shimon Peres, presidente di Israele (privo di poteri politici, ma ovviamente di grande autorevolezza).
Nel frattempo nel febbraio 2012 l’Alta Corte di Giustizia –in assenza di una Costituzione è il massimo organo giurisdizionale dello Stato– legiferava inammissibile la legge ‘Tal’ del 2002 sulla coscrizione obbligatoria perché violava il principio di uguaglianza. La legge confermava la consuetudine invalsa sin dal 1949 di consentire ai ragazzi haredim (‘pietosi’, popolazione di ultraortodossi) di evitare il servizio militare. Essi frequentano le yeshivot, scuole finanziate dallo Stato, ma dipendenti dal Rabbinato, per gli haredim appunto e destinate allo studio esclusivo della Torah, del Talmud e di testi rabbinici. La legge ‘Tal’ imponeva formalmente anche agli haredim la coscrizione obbligatoria, ma consentiva a loro di differire sine die il servizio militare qualora continuassero a studiare nelle scuole rabbiniche.
Il governo di coalizione di Benjamin Netanyahu entrava in fibrillazione. Avigdor Lieberman ministro degli Esteri e capo dello Yisrael Beiteinu (partito nazionalista e laicista), intenzionato ad approvare una legge egualitaria, confligge con Eli Yishai ministro degli Interni e capo dell’ultra religioso Shas che non riconosce il dettato dell’Alta Corte.
Netanyahu l’8 maggio con un colpo di scena alla Knesset evita la crisi di governo. Annuncia insieme a Shaul Mofaz capo di Kadima ai deputati esterrefatti, convocati per legiferare le elezioni anticipate per il 4 settembre, la soluzione della crisi. Infatti i 28 deputati del Kadima entrano nella coalizione governativa (Shaul Mofaz vice primo ministro) e garantiscono dall’ipotetica defezione del Yisral Beiteinu (15 seggi) e tanto più dello Shas (11 seggi). Sennonché appena 70 giorni dopo, il 17 luglio Mofaz dimissiona e il Kadima torna all’opposizione perché Netanyahu tergiversava nel presentare una legge ugualitaria sostitutiva della ‘Tal’. Emerge allo scoperto e paralizzante la ‘questione religiosa’, irrisolta dalla fondazione dello Stato.
Ne consegue che Netanyahu l’11 ottobre annuncia elezioni legislative anticipate per il 22 gennaio 2013 e il successivo 25 che il Likud e l’Yisraele Beiteinu si presenteranno agli elettori con un’unica lista. Netanyahu e Lieberman contavano di conquistare uniti un numero di seggi vicino alla maggioranza della Knesset (oggi rispettivamente 27 e 15 seggi) così da ridurre le pretese dello Shas, riferimento politico del Rabbinato sefardita, fermo nell’intenzione di opporsi alla decisione dell’Alta Corte in merito alla legge ‘Tal’; anche contrario come scritto sopra ad attaccare militarmente l’Iran senza l’intervento degli Stati Uniti. Un proposito di guerra condiviso da Netanyahu e Lieberman, rispettivamente presidente del Governo e ministro degli Esteri, leader dei partiti attualmente più forti della destra. Un calcolo probabilmente sbagliato. Recenti autorevoli sondaggi prevedono dopo le prossime elezioni una consistente riduzione dei 42 seggi oggi occupati alla Knesset dai due partiti uniti a vantaggio del Bayit Yehudi (‘Casa dei Giudei’, già Partito Nazionale Religioso), estrema destra religiosa e nazionalista, capitanato da Naftali Bennet, figlio di immigranti statunitensi e geniale imprenditore di una società di software la cui vendita lo ha reso ricchissimo. È programmaticamente impegnato a impedire uno Stato palestinese. Malgrado sia maggiore nella riserva e abbia servito in reparti d’élite, ha affermato alla televisione che se fosse ancora sotto le armi rifiuterebbe di eseguire ordini di smantellare insediamenti ebraici nella Cisgiordania (detta anche ‘West Bank’) anche se illegali. Avendolo attaccato per questa pubblica dichiarazione Netanyahu è calato nei sondaggi (“Haaretz”, 23 e 25 dicembre 2012). La tendenza teocratico-nazionalista della politica israeliana sembra irreversibile.
Nel pomeriggio del 14 novembre esplode la tensione con Hamas per il lancio di missili alcuni dei quali caduti alla periferia di Tel Aviv e Gerusalemme. Israele cade nella trappola (sebbene sia comprensibile la reazione al lancio di missili) e scatena la pesante offensiva aerea (sostitutiva di un attacco all’Iran?) ‘Pilastro di sicurezza’ e minaccia l’invasione della Striscia di Gaza. Dopo otto giorni in cui Hamas, malgrado un pesante numero di morti ed estese distruzioni non si astiene dal reagire, costretta dagli Stati Uniti ad accettare l’intermediazione dell’Egitto, Israele acconsente a una tregua e sospende nella serata del 21 novembre i bombardamenti aerei. Di fatto sia pure indirettamente riconosce Hamas e di dipendere militarmente e politicamente dagli Stati Uniti. Gaza paga con circa 140 morti, ma Hamas rimane indenne, mentre Israele esce dal conflitto a fuoco con l’efficacia del deterrente militare appannato e un prestigio diplomatico ridimensionato.
Venti di guerra con l’Iran non soffieranno probabilmente anche con il prossimo governo israeliano. Dipenderà dalla coalizione governativa, pronosticata ancora più a destra dell’attuale compagine ministeriale, ma soprattutto dai rapporti con gli USA (ciò non vuol dire che l’organizzazione militare israeliana di difesa dismetta, ovviamente come vuole il suo compito, di considerare il peggio).
A conclusione dell’anno si possono dedurre alcune considerazioni certamente, come sempre, opinabili, ma verosimilmente fondate.
Con la rielezione di Obama l’egemonia israeliana sulla politica americana in Medio Oriente degli otto anni di Sharon e Bush, in parte subita da Obama durante il primo mandato, ha mutato indeterminatamente segno.
Il voto contrario (29 novembre) degli Stati Uniti all’Assemblea Generale dell’ONU alla qualifica di ‘Stato osservatore non membro’ della Palestina, ‘Stato’ appunto (già solamente ‘ente osservatore’), smentisce solo in apparenza la svolta. La reazione immediata di Netanyahu (30 novembre), che annuncia la costruzione di 3.000 nuove abitazioni in territorio palestinese è paragonabile a un riflesso condizionato che mette a nudo un proposito in atto dal 1967: possedere la Cisgiordania senza annetterla e frammentare la popolazione palestinese. Il premier israeliano coglie l’occasione per annunciare l’urbanizzazione dell’area fra Gerusalemme Est e il popoloso insediamento ebraico di Maleeh Adumin spezzando il territorio palestinese in due tronconi con una cortina edilizia; un progetto per pregiudicare di fatto la costituzione di una entità autonoma palestinese nel cassetto dal 1975, allorquando si mise mano a Meleeh Adumin, oggi abitato da oltre 34.300 cosiddetti ‘coloni’.
Anche la contrarietà subito chiaramente espressa dal Dipartimento di Stato USA (risaputa e come sempre vana) con la conferma di 200 milioni di dollari all’Autorità Nazionale Palestinese confligge con la decisione di Netanyahu che ha bloccato i dazi doganali dovuti all’ANP. Un contrasto significativo, eppure risposta ancora debole al provvedimento di Netanyahu che è stato un palese schiaffo agli Stati Uniti, assicurati dai precedenti governi Sharon e Olmert che in quell’area non si sarebbe costruito. Fino a quando gli interessi da tempo assai forti che legano Washington a Gerusalemme prevarranno sui nuovi orientamenti geopolitici di Obama? Dipenderà dall’evoluzione politica in atto nei governi arabi, ma soprattutto dall’interesse americano allo scacchiere orientale.
Netanyahu è intervenuto nella campagna presidenziale con il proposito di mobilitare la comunità ebraica statunitense e i fiancheggiatori nella speranza di un suffragio vincente per Mitt Romney. È dell’11 settembre (“Haaretz.com”) un pesante attacco al Presidente americano e il successivo 27 all’Assemblea annuale dell’ONU dieci giorni prima delle elezioni, l’esplicita accusa, sebbene in tralice, di rifiutarsi di indicare la ‘linea rossa’ oltre la quale intervenire militarmente (esibisce un cartello con il disegno schematico della ‘bomba atomica’ prevista in possesso dell’Iran oltre una ‘linea rossa’, prossima alla conclusione paventata).
Da tempo superata la contesa armata con l’URSS, l’interesse strategico dell’America nel Medio Oriente è concentrato sul Golfo Persico, insostituibile via delle forniture di petrolio. Il minuscolo Bahrein densamente popolato, maggioranza scita, ospita, significativo deterrente nella regione, la maggiore base della Marina americana in quel teatro geo-politico. “The New York Times”, sia pure smentito da entrambe le parti, ha scritto di supposti contatti segreti del Dipartimento di Stato con l’Iran (“Il Giornale”, 22 ottobre). La non prevista cosiddetta ‘Primavera araba’, i cui esiti sono tuttora imprevedibili, ma salutata fin dall’inizio in Tunisia nella primavera 2011 da Obama, ha sconvolto i decennali equilibri nel Medio Oriente. Israele ha perso l’appoggio di sempre della Turchia, perno sud-orientale della NATO, caro a Washington (si scrive che per rompere l’isolamento la diplomazia israeliana prospetti un asse con Cipro-Grecia-Russia). Malgrado l’incommensurabile differenza di forza, Israele non è in grado di piegare l‘ostilità cruenta di Hamas ed è costretta ad accettare mediazioni per una tregua. Dal recente conflitto sanguinoso con Israele, Hamas, ‘terrorista’ per la comunità occidentale, è uscita diplomaticamente credibile e rafforzata a discapito della Autorità Nazionale Palestinese frustrata dal non più credibile ipotesi di Stato indipendente. L’irrisolta questione palestinese, pendente da 50 anni e oscurata da molti mesi dalla prospettiva dell’armamento nucleare dell’Iran, s’è confermata l’epicentro delle preoccupazioni internazionali per il Medio Oriente.
La politica estera israeliana appare sclerotizzata dagli anni del confronto USA URSS e dal seguente decennio di egemonia mondiale degli Stati Uniti, ma gli anni Novanta sono lontani. La Cina è definitivamente emersa come super potenza in competizione con gli Stati Uniti. Il ruolo internazionale della Russia è ritornato fra i protagonisti. La preoccupazione strategica degli Stati Uniti è concentrata, oltre che sul Golfo Persico, sui due mari della Cina –Mare Cinese Settentrionale e Meridionale– e intendono garantirsi alle spalle il mondo arabo.
Dovrebbe stupire che Israele, Stato moderno fra i più organizzati, paese che da decenni eccelle nel mondo per le realizzazioni nell’High-tech, patria di cervelli eccezionali, non abbia compreso la necessità geografica di escogitare una politica di rapporti distesi col mondo arabo soverchiante, piuttosto che confidare esclusivamente nella forza delle armi e nell’ombrello politico, finanziario e militare americano, probabilmente non più a lungo incondizionato. Lo impedisce l’impasse insolubile di non rinunciare alla Cisgiodania e nel contempo non annetterla, occuparla e amministrarla militarmente (da 45 anni), per non nazionalizzare 2.252.300 palestinesi, più i 396.700 gerosolimitani. Essi, sommati ai 1.122.000 arabi israeliani, raddoppierebbero circa il rapporto degli arabi, oggi di circa il 20%, con gli ebrei in Israele. Un rapporto di circa il 40% considerato intollerabile in quel paese ch intende rimanere ‘degli ebrei’. D'altronde la Cisgiordania, Giudea e Samaria, è popolata da 322.700 ebrei (senza contare i 196.178 a Gerusalemme Est; “Passia Diary 2012”) nazionalisti e di massima religiosi. Presumere sia possibile realizzare in quella terra ‘due Stati per due popoli’ è semplicemente chimerico e meraviglia che la diplomazia degli Stati Uniti faccia mostra di crederci ancora.
Francesco Papafava